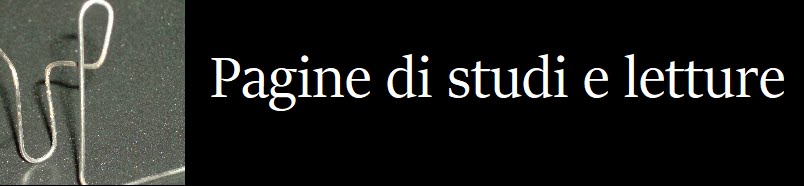Siamo
molto abituati ad un certo linguaggio visivo, sia perché siamo
immersi in una società della comunicazione che adotta criteri e
canoni comunicativi per noi usuali, sia perché è invalsa una
concezione per cui si afferma una automatica ed indiscussa identità
tra «verismo»
e «realismo»
lasciando alcuni spazi (rivelantesi pericolosamente ambigui), in cui
anziché la chiarezza oggettiva, tanto enfatizzata, prevale una
confusione ontologica che non è facile sciogliere. Questo perché
crediamo che esista uno stato dell'essere, il dato oggettivo, forse
anche la realtà materiale, avulsa, se non addirittura estranea, alla
manipolazione ideologica della narrazione comunicativa.
Una
illusione appunto, come l'opera di Umberto Eco ha mostrato, tuttavia
questa convinzione ci viene rafforzata da un altro convincimento,
creato pretestuosamente dalla fotografia, cioè che esiste
un'immagine che sia solo una mera rappresentazione mimetica della
realtà. Basta uno scatto fotografico ed ecco che digitalizziamo una
parte di realtà, la fissiamo (forse la congeliamo!) nell'istante
raccolto dallo shoot
fotografico. Un'idea che ci deriva da alcuni grandi fotografi, uno su
tutti Henri Cartier-Bresson, ma quest'idea si rafforza non perché
sia intrinsecamente vera, ma perché l'attuale nostro linguaggio
visivo è configurato in modo tale da confermarci in questa opinione.
A
questo cambiamento, di cui si può essere consapevoli solo tramite
una retrospettiva storiografica, ci si è giunti attraverso alcuni
momenti decisivi della nostra civiltà. A tal riguardo, l'opera
fotografica di Diane Arbus è di certo, uno di questi. Il suo
minimalismo fotografico ha modificato il nostro modo di intendere la
fotografia, perché non solo ha reso possibile ad un qualsiasi
amatore e/o cultore della fotografia di acquisire una legittimità
artistica, ma ha decretato anche la fine del modo tradizionale di
concepire la stessa fotografia. Nel 1967, la mostra al MOMA di New
York intitolata New
documents, a cui partecipa
Arbus assieme a Friedlanger realizza una svolta vissuta come epocale
dalla generazione successiva di fotografi (quella degli anni
Settanta), non tanto sul piano linguistico della immagine (la
rivoluzione si era già compiuta con Abbott, a.e.), ma proprio su
quello della “narrazione” ad opera dell'immagine fotografica. La
scelta dei soggetti, tratti per lo più dai ceti emarginati o
marginalizzati della grande metropoli americana, offre al pubblico
statunitense una galleria di immagine inusuali, mai viste e che
sconvolgono il pensiero benpensante dell'epoca. Lo scopo è
raggiunto, ma schiude un orizzonte di cui in parte si colgono tutte
le conseguenze. Arbus non ebbe grande consapevolezza di ciò che
aveva innescato, o forse ne ebbe solo una vaga intuizione, tuttavia
attraverso la sua opera il presunto realismo del fotoreporter ha
accesso all'immaginario del vivere ordinario e quotidiano della
società, invadendo quel paesaggio che è l'intimità individuale
della microstoria delle persone e che spesso è rimbalzata fuori dagli
schemi della Grande Storia dell'umanità.