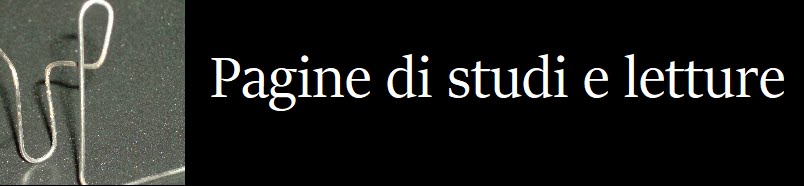O |
gnuno
di noi possiede un documento personale di riconoscimento, di solito una carta
di identità, ebbene se si consulta questo documento si trovano gran parte delle
informazioni che riguardano la nostra persona come il nome, il cognome, la data
e il luogo di nascita, il comune di residenza con la indicazione della via
compreso di numero civico, perfino la professione che allo atto della
promulgazione del documento è stata dichiarata allo ufficiale dello ufficio
anagrafe. Per quanto riguarda il tema di queste righe è bene soffermarsi su una
sezione in specifico di questo documento, sezione indicata con il titolo
«Connotati e Contrassegni salienti». In questa sezione si trovano le seguenti
voci con i rispettivi valori determinati, nel mio caso la sezione appare come
segue:
|
Voce della sezione |
Contenuto indicato
dal documento |
|
|
|
|
STATURA |
°°°°167 |
|
CAPELLI |
°°°°Castani |
|
OCCHI |
°°°°Castani |
|
SEGNI
PARTICOLARI ° |
°°°°Nessuno |
Personalmente, avrei qualche preferenza
e se mi fosse stato possibile avrei preferito trovare scritto in questa sezione
alla voce OCCHI magari lo attributo AZZURRI, ma guardando la fotografia a
corredo del documento sarebbe stato impossibile; forse, più fattibile la
informazione «BELLISSIMO» alla voce SEGNI PARTICOLARI, ma non mi pare che ci sarebbe
stato qualcuno a crederlo e ad affermarlo. In ogni caso, le varie attribuzioni
assegnate dal documento compongono una definizione di me stesso, utile
ovviamente non per una riflessione esistenziale o metafisica o psicologica del
sottoscritto, ma semplicemente per rendermi riconoscibile alla comunità.
Il sistema adottato dalla burocrazia nazionale
ricorre alla costruzione di un sistema di proprietà – e quei contenuti presenti
nella carta di identità sono da intendersi tali – con il quale operare una definizione
della persona a cui sono attribuite. In linguistica e in semiotica questo
procedimento descrive un Contenuto Molare [Eco 1996], cioè informazioni che
descrivono alcune caratteristiche specifiche di ciò a cui ci si sta riferendo;
il Contenuto Molare è già una informazione più pertinente e più aderente al
riferito, anche se a ben guardare ci si muove ancora nello ambito di una
connotazione molto generica, non proprio individualizzante, in quanto possono
esserci persone oltre me che sono alte 167 cm, che hanno capelli e occhi
castani e non presentare alcuna specifica caratterizzazione fisica tanto da
essere immediatamente riconoscibile. Infatti, fa fede la fotografia che è
allegata al documento a dare allo intero documento personale la sua intrinseca
validità e rilevanza significativa, perché la immagine fotografica funge da
referenza ostensiva, cioè da esemplare che potrebbe essere indicato con il
puntamento di un dito se fosse materialmente presente allo interlocutore:
ovviamente, questo meccanismo elude il fatto che anche la immagine fotografica
è a sua volta un segnale, certo diverso da quello di un cartello stradale, ma
molto più affine ai vari cartelloni pubblicitari.
Ecco dunque, delinearsi un tema
particolarmente interessante e a suo modo anche attuale, a causa del dibattito
molto caotico e scomposto sulla scienza, e cioè gli esiti effettivi della
composizione di un significato. Lo esempio che ho proposto può considerarsi un
piccolo modello su cui impostare il ragionamento a riguardo. Per molto tempo,
il problema della definizione dei contenuti scientifici è un tema strettamente
correlato alla attività di denotazione del soggetto. Nella interlocuzione, ma
anche nella composizione delle conoscenze scientifiche ci si muove, anzi ci si
muoveva pensando e credendo che il significato di un segno linguistico o di una
proposizione fosse determinato dalla sua effettiva correlazione con lo oggetto
del suo riferimento. Il linguista svizzero Ferdinand De Saussure (1857-1913) nel
suo noto Corso di linguistica generale
(1916) costruisce il circuito della comunicazione sul modello medievale della
struttura semiotica di signum-res e
quindi, il significato di un segno linguistico è inteso come la trasposizione
linguistica dello oggetto riferito come se fosse materialmente presente: di
qui, la idea molto tradizionale per cui il segno linguistico sia quella unità
utilizzata “al posto di” ciò di cui si sta parlando. La lingua insomma, è la
immagine virtuale e trasposta della realtà materiale e concreta, per cui la fonte
di senso sia delle attività linguistiche e semiotiche, sia delle singole unità
linguistiche e semiotiche rimane sempre la realtà concreta e materiale, cioè la
dimensione extra-linguistica.
Stesso discorso per le definizioni della
scienza, soprattutto dopo la svolta naturalistica avutasi con il noto dibattito
astronomico del Seicento e dopo lo imporsi del metodo scientifico che
privilegia la osservazione diretta della natura è evidente che la realtà
osservata e registrata dai sensi è la sede della rilevanza significativa di
qualsiasi asserto scientifico. I dibattiti teorici che dal Seicento in avanti
sono stati prodotti ammettono indistintamente questo tipo di dominio
empiristico nella formulazione del sapere scientifico, dominio che è diventato
il precetto per la definizione di un meccanicismo materialistico formulato
dallo scienziato inglese Isaac Newton (1642-1726), ma imposto culturalmente
dall’Illuminismo francese con figure come il matematico e astronomo francese
Pierre Simon Laplace (1749-1827) e il matematico di origini italiane
Joseph-Louis Lagrange (1736-1813). Si fatica molto prima di accorgersi che la
formulazione linguistica degli stessi contenuti scientifici contiene in sé
alcune falle per così dire inevitabili e non più solo sul piano logico, come
rivela in fondo il formalismo meccanicistico del Tractatus logico-philosophicus (1919) di Ludwig Wittgenstein
(1889-1951). Infatti, se figure come Giovanni Vailati (1863-1909) espressero l’esigenza
e l’urgenza di ragionare con maggiore consapevolezza sui sistemi rotazionali e
sulle procedure comunicative del sapere scientifico, tuttavia la soluzione che
veniva avanzata rimaneva saldamente ancorata alla attività denotativa e ad una
costruzione logico-semantica degli stessi contenuti; grossomodo come se dai
trattati di logica di Aristotele non fossero trascorsi i diciotto secoli che ci
separano dallo antico e illustre filosofo greco. Eppure, lo stesso Aristotele
aveva rilevato una bizzarra anomalia e metteva in guardia tutti coloro che si
occupavano di scienza di badare a questa anomalia. La anomalia in questione si
rivela in particolare nei capitoli delle Categorie
e riguarda il fenomeno della polisemia. Lo antico filosofo muoveva dalla
posizione che il significato di qualcosa fosse una determinazione esclusiva,
cioè una composizione univoca dei contenuti che riguardassero lo oggetto
riferito; in linea di principio, ogni forma di scostamento rispetto a questa
univocità introduce una contraddizione nel significato e dunque, un problema in
termini di individuazione e comprensione filosofico-scientifica. Tuttavia, lo
stesso Aristotele conveniva che in alcuni casi la definizione dl riferito
ammettesse questo fenomeno polisemico in maniera “strutturale”, come nel caso
appunto, del concetto filosofico di to’ ‘ón,
cioè della espressione che descrive il tema filosofico dello «essere».
È noto che il razionalismo logico di
Aristotele si è impegnato a costruire un sapere che fosse il meno
contraddittorio e ambiguo possibile, tanto che la stessa struttura del
sillogismo scientifico forniva criteri e metodi retorici e formali per
determinare argomenti che avessero una validità scientifica indubbia e
indiscutibile. Ma la battaglia di Aristotele contro le anomalie linguistiche
della comunicazione e le contraddizioni sconcertanti della logica si scontrano
nelle affermazioni sensate e alquanto inorridite di una piccola bambina di nome
Alice: lo stesso Aristotele ne sarebbe stato sorpreso, malamente stupito.
La svolta linguistica del XX secolo non
ha modificato ciò che una lunga tradizione letteraria e scientifica ha
ampiamente consolidato, vale a dire la affermazione di un forte dominio
semantico, dominio su cui si basa la idea di un «pensiero forte», cioè di un
sistema culturale e scientifico per nulla incline a negare validità non solo
alle proprie procedure e meccanismi, ma anche ad insinuare il dubbio che la via
del metalinguaggio sia in fondo, la sconfessione della semplificazione
logico-metafisica di Guglielmo di Occam (1288-1347) e che forse, il rasoio
della scienza ha necessità di essere limato. In questo paesaggio, il successo
della semiotica definisce la affermazione di una attività che ha il ruolo e la
funzione di verificare i procedimenti linguistici che agiscono nella stessa
composizione dei significati scientifici, il che di per sé è contraddittorio
rispetto al fatto che la fonte della conoscenza è solo la realtà sensibile, gli
eventi della natura e i fatti empirici. In effetti, la attività semiotica
sembra estranea alla attività scientifica, almeno in senso stretto. Ciò ci
viene confermato da una distinzione formulata da Umberto Eco nella prefazione
citata dalla antologia di Augusto Ponzio (n.1942) [Ponzio 1976: pp.164-67] a I sistemi di segni e lo strutturalismo
sovietico [AAVV, Milano 1969] che indica come la attività scientifica sia
legata a sistemi non direttamente collegati al sistema della cultura, cioè a
quei meccanismi ordinari propri di una società, e ciò a causa del formalismo
simbolico dei suoi contenuti: la scienza compone i propri contenuti secondo regole
e criteri che non sono quelli della comunicazione ordinaria, ma sono
specialistici e autoreferenziali. Pertanto, lo interesse della semiotica al
discorso scientifico è limitato soltanto a quel momento in cui la scienza
diventa un fatto culturale, cioè quando i suoi contenuti iniziano ad avere una
diffusione nella opinione pubblica, altrimenti la teoria scientifica produce
segni e significati “alieni” rispetto al pensiero sociale. E tuttavia, il
linguista italiano Tullio De Mauro (1932-2017) parlando di «arbitrarietà del
segno linguistico» indica
«la
nozione, già aristotelica, di immotivazione naturalistica della forma del segno
rispetto al suo valore referenziale. (…) non c’è alcuna necessità d’ordine
naturale per cui il referente debba essere individuato da un ordine fisico: [la
necessità] sorge soltanto all’interno d’un determinato codice, una volta che si
sia stabilito di accettarlo rispettandone le convenzioni» [cit. Ponzio 1976:
pp.319-20].
È evidente che tale impostazione
rivelerà una certa insoddisfazione teorica, perché suggerisce che le attività
legate alla scienza siano di altra natura rispetto alle ordinarie attività
cognitive dell’individuo. Inoltre, suggerisce una specializzazione dell’intera
attività semantica e una griglia ontologica che possiedono un sistema di
“autodiagnosi” dei propri contenuti fondamentalmente differenti da quelli
ordinari e oggetto di interesse della stessa semiotica. Ma a lungo andare tale
approccio si rivelerà non più sostenibile e lo stesso Eco è tra quelli (forse il
primo) a denunciarne i limiti. Una posizione trasversale rispetto al panorama
culturale europeo che viene a descriversi costantemente lungo una serie di
libri del semiologo e soprattutto intorno ad un tema che prenderà sempre più
rilievo nelle tesi del semiologo italiano, cioè il tema della enciclopedia.
Avevo tentato di descrivere questo
percorso in uno scritto dal titolo Il
problema tassonomico delle definizioni scientifiche, che pensavo di mettere
qui sul blog, ma l’eccessiva estensione mi ha scoraggiato a farlo; ecco perché
ho optato per una esposizione più sintetica e forse soltanto accennata di
queste righe, tuttavia c’è da fare alcune precisazioni. Anzitutto, pur essendo
costante l’interesse di Eco al tema della enciclopedia, questo interesse però
si focalizza esclusivamente sui termini di una distinzione tra enciclopedia e
dizionario che con il passare del tempo diventerà sempre più rilevante e
decisiva nella composizione del concetto di enciclopedia, che diventerà un tema
fulcro della teoria della referenza e della composizione del significato
nell’opera saggistica dopo la metà degli anni Novanta del secolo scorso.
Inoltre, il concetto di enciclopedia diventa la risposta migliore che si possa
formulare per risolvere alcune fondamentali contraddizioni affiorate nella
teoria linguistica, soprattutto per quanto riguarda l’attività scientifica
della classificazione tassonomica: il criterio semantico non può intervenire
con soddisfazione nel dirimere le eventuali ambiguità tassonomiche e le controversie
sulla natura e trasmissione dei contenuti della scienza, proprio perché esiste
non solo una divergenza lessicale e contenutistica tra la semantica scientifica
e la semantica propria e acquisita in modo ordinario da chi non ha
specializzazioni scientifiche. A ciò si aggiunge un fatto semiotico
sorprendente e che già era emerso in [Eco 1975], cioè che la composizione dei
significati non ha sempre un’origine denotativa. Se l’analisi dei lessemi nello
spiegare il contenuto di una definizione, dunque di un significato ricorre
sovente alla referenza ostensiva, cioè alla pratica di indicare puntando con un
dito il referente del segno linguistico (esempio, /Luna/ significa «Luna» e
così dicendo si punta un dito verso il satellite naturale della Terra), tale usanza
non risolve i problemi di comprensione (e di persuasione) legati alla
comunicazione del contenuto scientifico. Affinché la comunicazione scientifica
dei propri contenuti sia efficace occorre una effettiva integrazione tra due
sistemi semantici non solo eterogenei, ma anche incompatibili tra loro.
Il concetto semiotico di «enciclopedia»
diventa lo strumento concettuale con cui poter risolvere queste controversie,
ma significa iniziare a pensare la denotazione non più in termini di referenza
ostensiva, ma come un sistema complesso e arzigogolato di connotazioni che
raccolte insieme contribuiscono non solo a comporre il significato, ma anche a
fornire (seppur in via di indirizzo) una qualche spiegazione. Esempio, se il
lessema /balena/ viene spiegato dallo zoologo elencando un sistema di proprietà
(semantica da dizionario/vocabolario) da cui a sua volta fa derivare la
definizione scientifica grossomodo simile a questa uguaglianza:
«MAMMIFERO
+ ACQUATICO + APPARATO POLMONARE + PRESENTE NEI MARI DEL NORD»,
definizione dove le proprietà ACQUATICO
e APPARATO POLMONARE rivelano la famiglia di appartenenza dell’animale, cioè a
quella dei cetacei. Ora, ammesso che un qualsiasi interlocutore abbia una idea
o un’immagine cognitiva dell’animale, la definizione può rivelare degli inganni
e magari far pensare a chi non è zoologo che la «balena», essendo un animale
acquatico, sia più simile ad un comune pesce che non al proprio cane o gatto.
Ad aiutare nella comprensione della definizione sopra presentata possono intervenire
attribuzioni che derivano da un insieme di connotazioni non tutte derivanti
dalla esperienza diretta in mare o ad un acquario pubblico, come nel caso della
letteratura, che oltre ad essere piena di una variegata e multiforme
caratterizzazioni che possono intervenire nella connotazione del riferito di
una definizione scientifica, per cui chi ha letto il noto romanzo di Hermann
Melvile (1819-1891), Moby Dick (1851),
può avere oltre che il Tipo Cognitivo di /balena/, anche una “giusta”
definizione del suo significato, ma anche pregiudizi e imprecisioni
contribuiscono a formulare significati che si riversano nel pensiero sociale.
Ma questa è un’altra storia.
L’introduzione delle connotazioni
letterarie rivela una natura composita di una qualsiasi definizione, anche di
una definizione scientifica come si è visto e ciò costringe a dover ammettere
che la spiegazione di un contenuto specialistico come può essere appunto, una
definizione scientifica deve avvalersi di uno strumento che non sempre
interviene a dirimere le controversie come il dizionario. A volte, la
spiegazione e comprensione di un significato può realizzarsi tramite un
precedente contenuto acquisito magari secondo canali di informazione e secondo
mezzi di informazione differenti da quelli consueti – o quelli deputati
all’acculturazione della società come famiglia e scuola – e ciò nonostante non
è detto che il contenuto sia del tutto fuori campo: basti pensare all’opinione
di Eco sul valore dei fumetti contemporanei nella composizione dei significati
diffusi socialmente. Ma affinché ciò possa realizzarsi occorre una prospettiva
generale e complessiva delle caratterizzazioni che sono attribuibili ad un
riferito che può determinare una selezione, un aggiornamento e una scelta delle
attribuzioni corrette al significato in questione. È l’idea di Enciclopedia
Massimale che Eco espone in [Eco 2012] con la quale mette fine ad una storia di
controversie tra dizionario e enciclopedia che risale fino ad epoche antiche,
ma dà inizio a possibilità di classificazione e a strutture enciclopediche
(esempio le reti neurali alla base della Intelligenza Artificiale) dove il
concetto semiotico di «enciclopedia» non indica più il concetto epistemologico
di mathesis, cioè di sapere
universale [Michel Foucault 1966], ma indica un sistema dove intervengono
specifiche condizioni che rende questo sapere un materiale di informazioni
suddiviso e divisibile in campi locali, facilmente rintracciabili mediante una
ricerca in chiave tematica e che descrive tutte le caratterizzazioni relative
all’argomento. A riguardo, alla base di questo concetto non c’è più la
tradizionale concezione di una universalità dei contenuti, ma la attività di
una struttura, costruita intorno ad un criterio regolativo, che configura
percorsi tematici, articolati e complessi, con cui comporre definizioni e
contenuti di ogni genere, compreso i contenuti della scienza.
A suo modo, il Discorso Preliminare (1751) del filosofo francese Jean-Baptiste Le
Rond D’Alembert (1717-1783) che introduce la nota opera dell’Illuminismo
francese, cioè l’Enciclopedia indica
due caratteri che anticipano l’idea di criterio
regolativo alla base della Enciclopedia Massimale di cui si diceva. Il
filosofo francese offre due caratterizzazioni della Enciclopedia, anzitutto quella di essere un «mappamondo» e quella
di essere un «labirinto». Sono due caratterizzazioni di estremo interesse e che
più di quanto potesse immaginare D’Alembert colgono due attività di grande
potenza e proficuità, almeno per come la civiltà umana ha imparato a definire e
a comporre le proprie attività scientifiche e culturali. Il concetto semiotico
di «enciclopedia» risolve molti problemi di comprensione e di orientamento,
tuttavia non è un concetto predeterminato, ma viene a configurarsi nell’articolato processo di accumulazione di informazioni e
di contenuti; in qualche caso, questo concetto è anche alla base di clamorosi
fraintendimenti che sono imputabili per lo più al modo in cui viene configurata
la struttura a rete della stessa enciclopedia (è il caso della Enciclopedia
Ontologica formulata da James Joyce (1882-1941) [Eco 2012]) che può essere
causa e motivo di quel fenomeno di ridondanza semantica che diffonde contenuti
perverse o configurazioni scellerate di uno o più significati; in questo casi
si deve operare aggiornando o riformulando intere sezioni di enciclopedia e
forse addirittura dell’intera stessa enciclopedia. Ma ciò significa anche che,
senza scomodare civiltà extraterrestri, essendo le stesse definizioni
enciclopediche un condensato di connotazioni, alcune fissate tramite
convenzioni sociali, la traduzione di esse in una lingua ed in un sistema
culturale che non adotta le convenzioni fissate per le definizioni
enciclopediche, la traduzione dicevo, appare molto complicata e non sempre
coronata da successo: questo è un aspetto non considerato nel puzzle proposto
da un libro del matematico Martin Gardner (1914-2010) riguardante la situazione
provocatoria di poter ridurre un intero volume della Enciclopedia Britannica in una stringa numerica [Gardner 1978].
Porto Empedocle, 25/11/2021