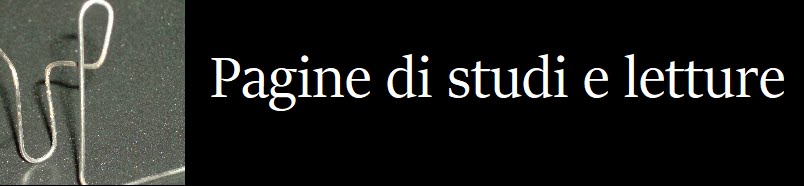#QuadratoMagico, #Logica, #Aristotele, #Hegel, #MartinGardner, #RobEastaway, #Matematica, #Filosofia, #ChaimPerelman, #LewisCarroll, #BertrandRussell, #GeorgWilhelmFriedrichHegel, #Platone, #Sillogismo, #Euclide, #VasilijKandinskij, #JurgenHabermas
La figura del quadrato è un
oggetto molto noto, così come tutte le figure della geometria piana compresi
quasi tutti i solidi e i poligoni corrispondenti, e fa parte di quel mondo
astratto che le scuole elementari iniziano a presentare ad ognuno di noi fin da
bambini. Una familiarità che ci descrive il quadrato come una forma semplice,
ma dotata di alcune proprietà:
- ·
è un oggetto composto da 4 lati uguali e nel
caso che non siano uguali si ha a che fare con un rettangolo;
- ·
è divisibile in vari pezzi, in genere due o
quattro a seconda di come sono tracciate le diagonali, ma le sezioni possono
realizzarsi in diversi modi;
- ·
ha una formuletta semplice semplice per la
determinazione del suo perimetro, lato x lato, ed una altrettanto facile da
ricordare per la determinazione della sua superficie, lato al quadrato;
- ·
infine, il quadrato è la somma di due triangoli
rettangoli, quelli stessi resi famosi dal noto Teorema di Pitagora, o invariabilmente dal Teorema di Euclide, da cui si evince la natura intera dei numeri,
ma anche l’esistenza di una classe ulteriore di numeri, i numeri irrazionali, quelli per i quali la radice di 2 è un numero
impossibile, perché inesistente.
In ogni caso, la geometria non
è l’unico spazio in cui possiamo trovare il quadrato. La forma del quadrato ha
avuto nel corso della storia culturale della civiltà europea diverse
applicazioni, alcune delle quali non per forza legate ai costrutti geometrici,
anche se la geometria - come è noto – per molti secoli ha rappresentato l’unico
e potente strumento della speculazione astratta umana.
Di forme di quadrato dicevo,
ce ne sono molte, come molte sono le applicazioni a cui si presta il quadrato,
a.e è un antico gioco cinese (cfr. Tangram)
o un diabolico rompicapo greco (l’Ostomachion
di Archimede), ma è anche la forma astratta di una schematizzazione algoritmica,
lo spazio operativo di una trama combinatoria. Ed è appunto, su quest’ultimo
aspetto che si concentra quanto segue.
Per secoli la filosofia ha
dato di sé la rappresentazione di un’attività razionale e nel gergo comune ciò
significa anche e soprattutto, un’attività logica, il che è vero, ma dipende
dalla definizione di “ragione” e di “razionalità”. Gli antichi filosofi greci
si erano sforzati di dare una precisa definizione a questo carattere e per lo
più, dall’antico filosofo ateniese Platone in avanti definiscono come
“razionale” quel contenuto che si mostra universalmente valido, costante ed
immutabile e “razionale” quell’attività che ricerca proprio questo tipo di
contenuti. Questa definizione finisce per essere il discrimine in seno alla
produzione dei discorsi, vale a dire a fissare una pregiudizievole distinzione
tra il discorso scientifico da un qualsiasi altro discorso della comunicazione
ordinaria. È l’antico razionalismo greco a spiegarci in cosa consiste questa
discriminante ed in particolare la filosofia di Parmenide di Elea, il quale non
solo fissa rigorosamente questa differenza in seno ai discorsi umani, ma impone
anche una fondazione linguistica a questa differenza. Nel frammento n.3 del suo
Poema sulla natura Parmenide afferma l’unità decisiva tra le strutture
sintattiche del linguaggio e le strutture della realtà dei fenomeni: La
comprensione umana del mondo e degli eventi fisici è possibile perché non c’è
nessuna differenza tra i significati riferiti dagli eventi ed il sistema
semantico e concettuale dell’intuizione linguistica. La sensibilità umana ha sì
esperienza del mondo, ma quest’esperienza diventa conoscenza e potere perché
esiste una diretta corrispondenza tra l’uomo e la natura: dobbiamo attendere
alcuni secoli ed arrivare alla filosofia di Georg Wilhelm Friedrich Hegel per vedere
infranto drammaticamente questo scenario parmenideo e per la natura la comparsa
dell’idealismo hegeliano sarà veramente drammatico!
In ogni caso, Parmenide fissa alcuni principi
da cui l’intera filosofia greca farà fatica a distaccarsi e che sono quelli
espressi dall’unità tetica dell’essere e dall’inesistenza del non essere,
“L’essere è e non può non essere” – dice Parmenide – “il Non essere non è e
quindi non può essere”. È l’esclusione di una via di mezzo, di una qualche
forma di conciliazione con la quale il filosofo di Elea scaccia dalla
riflessione filosofica l’insorgere di qualsiasi tipo di contraddizione. Ciò si
tradurrà nel pensiero logico nel noto principio del tertium non datur, o altrimenti noto come principio di non
contraddizione. Principio che regolerà l’argomentazione logica e buona parte
della produzione filosofica fin dalla filosofia antica, se sospendiamo da
questa ricostruzione la filosofia di Platone che si muove su direzioni
teoretiche molto differenti da quello che sarà la storia della filosofia e del
pensiero europeo. A tal riguardo, colui che più di tutti influirà nella rappresentazione
europea della ragione e della razionalità è l’antico filosofo di Stagira,
Aristotele, precettore di Alessandro Magno ed inizialmente uno dei discepoli
dell’Accademia del già menzionato Platone.

Il contributo aristotelico al
pensiero logico è dato da un ampio corpus di trattati aventi per oggetto
proprio le strutture fondamentali del ragionamento umano. L’intento del
filosofo è quello di fornire un organon, uno strumento con il quale preparare
l’intelletto umano ai livelli ulteriori di speculazione, rappresentati nella
sua filosofia dalla metafisica, per cui lo studio della logica deve intendersi
propedeutico alla metafisica e pur tuttavia, non del tutto autonomo ed
indipendente dalla teoria dell’essere che il filosofo fornisce appunto, nei libri
della Metafisica. Persiste dunque, in Aristotele l’idea di fondo parmenidea,
vale a dire che a fondamento della realtà manifesta del discorso umano vi sia
una struttura precedente e che sia in fondo “aliena” dal piano degli eventi: la
teologia cattolica trasformerà proprio questo piano nella realtà della presenza
trascendente di un Essere personale. Pertanto, il contenuto delle Categorie,
degli Analitici Primi, degli Analitici Secondi e dell’Interpretazione vuole
chiarire i funzionamenti che agiscono nella comunicazione ordinaria e tuttavia,
il motivo per cui i procedimenti intellettuali espressi da questa comunicazione
agiscono in siffatti modi deriva dal piano che vi presiede: c’è una specie di circolo in questo ragionamento, forse influenza platonica, ma che rivela quanto
stringente sia il legame che l’attività filosofica ha con le strutture
sintattiche. A tal riguardo, non c’è solo l’esigenza di chiarire i meccanismi
che presiedono alla composizione dei discorsi, ma vi è anche l’esigenza di una
meccanizzazione della produzione intellettuale. In pratica, Aristotele avverte
l’esigenza di costruire un meccanismo logico con il quale non solo verificare
la correttezza analitica dei contenuti usati in sede di discorso, ma anche di
produrre argomenti validi ex novo e che abbiano valore scientifico. Al
riguardo, l’antico filosofo elabora la struttura del sillogismo.
Per maggiori informazioni sul
sillogismo e sulla sua storia si può consultare un qualsiasi manuale di logica
e più in generale di storia della filosofia occidentale, qui mi limito soltanto
a dare una descrizione sommaria e comunque tesa a mettere in rilievo
l’argomento che mi interessa. Il sillogismo aristotelico è un costrutto logico
di asserti la cui trattazione è affidata ai capitoli degli Analitici Primi.
Esistono diversi tipi di sillogismi, tuttavia quando non viene specificato ci
si riferisce al sillogismo categorico, che è la struttura logica più importante
nella filosofia aristotelica, in quanto è quello dallo alto valore assertivo e
scientifico. La struttura del sillogismo prevede la composizione iniziale di
due asserti che fungono da premesse logiche (la prima detta Premessa Maggiore, mentre la seconda è
detta Premessa Minore) ad un terzo
asserto che funge da argomento o semplicemente da conclusione del sillogismo.
Ruolo fondamentale nel sillogismo – in qualsiasi sillogismo – è la posizione
del termine medio, cioè di una parola più raramente una predicazione o
addirittura un pezzo di proposizione (tranne se escludiamo l’aggiustamento
recente in senso retorico fatto da Chaim Perelman), che agisce nell’ambito del
costrutto come elemento di raccordo, ma soprattutto come termine di
congiunzione. L’azione di questo termine è fondamentalmente quello di
distribuire all’interno del sillogismo le proprietà e lo spazio semantico che
andranno a caratterizzare il significato linguistico ed il valore ontologico
della conclusione. Per tale ragione, Aristotele discute di figure, cioè dei diversi modi attraverso cui può realizzarsi la
composizione e quindi, la combinazione degli elementi di un sillogismo. Ora, il
termine medio occupa otto posizioni nello ambito delle due premesse, le
combinazioni possibili sono due elevato ad otto 256, ma Aristotele riconosce
solo 19 figure valide (qui elencate).
|
Prima figura
|
Seconda figura
|
|
Barbara
|
Cesare
|
|
Celarent
|
Camestres
|
|
Darii
|
Festino
|
|
Ferio
|
Baroco
|
|
|
|
|
Terza figura
|
Quarta figura
|
|
Darapti
|
Baralipton
|
|
Felapton
|
Celantes
|
|
Disamis
|
Dabitis
|
|
Datisi
|
Fapesmo
|
|
Bocardo
|
Frisesomorum
|
|
Ferison
|
|
Quest’elenco è composto da
nomi arbitrari che nella filosofia medievale (quella che li ha proposti) hanno
solo una funzione mnemonica, cioè serve a farli ricordare, tuttavia essi
chiariscono la natura delle premesse e la posizione del termine medio
nell’ambito del sillogismo. Le regole da seguire sono le seguenti:
- le
prime due vocali del nome indicano rispettivamente le due premesse del
sillogismo;
- la
vocale “a” indica le proposizioni dal valore universale, la vocale “e” quelle
negative universali, la vocale “i” le proposizioni particolari affermative, mentre
la vocale “o” quelle particolari negative.
Pertanto, se si considera a
titolo di esempio la figura Celantes, essa è un modo di quarta figura composta
da una premessa universale negativa (Premessa
maggiore), una premessa universale affermativa (Premessa Minore) da cui deriva come conclusione una proposizione
universale negativa. E così per tutte le altre figure, le quali sono tutte
oggetto di un processo di riduzione detto di conversione, vale a dire che la composizione dei termini in sede di
sillogismo non segue la combinazione numerica o posizionale, ma una
combinazione basata sull’inferenza immediata, pressappoco sul modello della
Prima figura (il noto modo Barbara). Ciò determina vari aggiustamenti durante
la composizione del sillogismo, ma anche quella selezione delle modalità che ha
portato l’antico filosofo a ridurre a solo poche figure valide il sillogismo.
L’idea di logica che presiede nel sillogismo aristotelico è un modello
causalistico, in quanto i rapporti tra le proposizioni sono inferenze di tipo
causale, e soprattutto basato sull’evidenza intuitiva delle verità contenute o
esposte dal sillogismo. Questo modo di costruire gli argomenti logici definisce
un sistema interno di autoevidenza che verifica da sé la validità dei contenuti
espressi.

Nei sistemi logici attuali
questo tipo di funzionamento logico non interviene più nella conoscenza
scientifica della realtà, anche se in alcuni settori della produzione
intellettuale umana persiste ancora, e ciò non solo perché il formalismo logico
attuale non è lo stesso formalismo qui descritto, ma anche perché ad un certo
momento della storia logica della civiltà europea il modulo sillogistico entra
palesemente in crisi, diventando esso stesso motivo di una sconcertante
descrizione della realtà inaccettabile e per nulla plausibile. E tutto ciò per
colpa di una bambina di nome Alice.
È in questo particolare
percorso della logica europea che s’inserisce la figura di Charles Lutwidge
Dodgson, noto con lo pseudonimo di Lewis Carroll e che darà una spallata
definitiva al mondo sillogistico tradizionale, molto prima che la ricerca
logica iniziasse ad orientarsi in direzione dei sistemi formali e del
simbolismo astratto (o matematico) con il sistema binario di Boole. Per avere
una rappresentazione degli esiti intollerabili del sillogismo basta leggersi il
noto romanzo dello stesso Carroll, Alice
in wonderland, ma in altri libri, più orientati alla saggistica sistemica,
si possono ravvisare, seppur per gioco, i limiti di una logica basata ancora
sul sillogismo aristotelico. Consideriamo il seguente sillogismo tratto da Symbolic
Logic del 1896, nella traduzione italiana di Carla Muschio (ed.it.
1998):
|
a) Le imprese
amministrate male non danno profitti.
|
|
b) Le ferrovie non sono
mai amministrate male.
|
|
c) Tutte le ferrovie
danno profitti.
|
Il sillogismo menzionato non
ha quell’immediatezza intuitiva che il sillogismo classico prevede, tuttavia è
un costrutto sillogistico, perché mette in relazione contenuti logici
differenti da cui trarre un argomento, in questo caso generalizzabile. In effetti,
pur nella sua vaga somiglianza al sillogismo aristotelico è evidente una
differenza fondamentale da quello e cioè, che non ha quel rigore formale
previsto da Aristotele e soprattutto ha una distribuzione dei contenuti dalle
premesse all’argomento molto farraginoso, tuttavia più del sillogismo classico
questi asserti sono composti e combinati tra loro in funzione non del loro
intrinseco significato, ma in base alla regola compositiva esteriore del
sillogismo: in pratica, si prendono tre asserti e li si collegano tra loro in
qualche modo. Ecco cosa accade.
La contraddizione anziché
essere estinta dal sillogismo, sembra in fin dei conti muoversi proprio
attraverso il costrutto e sembra quasi la validità dell’argomento derivi da una
specie di riduzione all’assurdo delle altre verità espresse nelle premesse.
Infatti, l’asserto a) rivela una verità che se non è oppugnabile, è di certo molto
ambigua, in quanto una cattiva gestione non pregiudica necessariamente il realizzarsi
di profitti da parte di terzi: è logicamente ammesso (moralmente no, ovviamente)
che alcuni soggetti economici che operano nello indotto creato da
un’amministrazione pubblica possano avere soddisfatto il loro interesse comunque
dalla gestione anche male accorta di una qualsiasi amministrazione pubblica– senza
incorrere per forza nella frode, ma a.e., uno spreco di risorse pubbliche, che
è una forma di mala gestione, po’ generare profitti a chi lucra sugli
investimenti del soggetto pubblico. Proseguendo, l’asserto b) riproduce un caso
specifico di quanto generalizzato nella premessa maggiore e che a ben guardare
può considerarsi un luogo comune, ma che a sua volta deve intendersi come quell’eccezione
confermante la regola: infatti, se il cattivo funzionamento del sistema
ferroviario può considerarsi un luogo comune, il fatto che sia così diffuso
propende per la sua validità e rende la sua contraddittorietà un carattere
della verità sommaria già espressa. Da notare che nel sillogismo aristotelico è
escluso qualsiasi intervento logico contraddittorio, tanto che di preferenza si
tende a costruirlo con asserti positivi, mentre gli asserti negativi tendono ad
essere collocati nella premessa minore (forse per fare meno danni al movimento
del pensiero). Ora, per non invalidare il sillogismo, la negazione espressa
nelle premesse deve distribuirsi anch’essa nell’argomento del sillogismo, ma come
può evincersi dalla conclusione l’asserto è affermativo e per di più esibisce
un valore ontologico universale: infatti, è esperienza comune che la presenza di
una ferrovia, indipendentemente da come venga gestita, produce un indotto, cioè
profitti più o meno estesi a soggetti terzi, il che appare in realtà, un
controsenso logico (non sense) rispetto
alle premesse prima formulate.

La coerenza dell’argomento,
che nel sillogismo classico è interamente affidata alla struttura formale, cioè
alla selezione dei modi (o figure) validi che non lo inficiano, è affidata
invece, esclusivamente alla struttura della stessa combinazione. E poco importa
se l’intero movimento del pensiero si muove sull’insensatezza di quel che viene
espresso evidentemente dagli asserti. L’acume di questi sillogismi, elaborati
da Carroll per lo più come enigmi e giochi, consiste proprio nel mettere in
crisi un modello logico che mostra ampiamente il suo essere obsoleto: l’andamento
dei valori ontologici degli asserti ricorda un poco le operazioni algebriche
dei numeri relativi, in base alle quali due numeri negativi sommati assieme
producono un numero positivo; ma ciò accade perché prevale la forma e la
struttura, cioè le condizioni esteriori su cui s’imposta una relazione, e non
il contenuto. È quanto ben sottolineato da Muschio nella premessa ad una
piccola raccolta di sillogismi di Carroll da cui ho tratto quello menzionato, e
cioè che quel che conta in questi costrutti è la correttezza del procedimento
logico (eguale convinzione l’avrà il logico e matematico inglese Bertrand
Russell nei Principi di Matematica, 1908) e non la verità ontologica degli
asserti, il che significa che è del tutto irrilevante ai fini della
composizione logica la fondazione metafisica dell’asserto medesimo: ciò è fuori
dall’orizzonte della filosofia e della logica aristotelica.
A questo punto è facile
evincere che l’idea portante della logica aristotelica sia appunto,
l’eliminazione di ogni forma di contraddizione che può verificarsi in seno ai
contenuti che compongono un qualsiasi sillogismo, sia esso un sillogismo
scientifico, sia esso un semplice sillogismo retorico. Ciò significa che il
contenuto di verità del sillogismo non dipende dalla sua struttura
combinatoria, ma dall’insieme di connotati e di proprietà che si riconoscono ad
ogni singolo asserto, cioè se tra le premesse del sillogismo troviamo un
asserto palesemente falso o improbabile, es. “un mammifero quadrupe con indosso
un paio di ali vola”, tutto l’intero sillogismo è invalidato. Le relazioni che
intercorrono tra gli asserti di un sillogismo non sono rapporti di
combinazione, o meglio lo sono, ma Aristotele impone una limitazione che gli
deriva dalla sua metafisica.
Nei sistemi logici attuali non
esiste questa visione aristotelica e per lo più è proprio la struttura
combinatoria a definire la verità dell’argomento prodotto e non il contenuto
espresso nelle sue singole premesse. Facciamo un esempio. Si consideri la
seguente somma:
1 + 2
+ 3 + 4 + 5 = 15 (a)
In virtù della proprietà
distributiva degli addendi, la somma (a) equivale alle seguenti somme:
(1 +
2) + 3 + (4 + 5) = 15
1 + (2
+ 3 + 4) + 5 = 15
(1 +
2) + (3 + 4) + 5 = 15
(1 +
5) + 4 + (2 + 3) = 15
1 + (2
+ 4) + (3 + 5) = 15
…
Ma la stessa somma può
scriversi, in virtù della teoria dell’algebra, nel seguente modo,
1 + (1
+ 1) + (1 + 1 + 1) + (1 + 1 + 1 + 1) + (1 + 1 + 1 + 1 + 1) = 15
Oppure come,
1 + (1
+ 1) + (1 + 1 + 1) + (1 + 1 + 1 + 1) + (1 + 1 + 1 + 1) = 15 – 1
1 + (1
+ 1) + (1 + 1 + 1) + (1 + 1 + 1 + 1) + (1 + 1 + 1) = 15 – (1 + 1)
1 + (1
+ 1) + (1 + 1 + 1) + (1 + 1 + 1 + 1) + (1 + 1) = 15 – (1 + 1 + 1)
…
Queste scritture non sono solo
una diversa notazione del medesimo rapporto di equivalenza costituito dalla
somma (a), ma è anche un modo per mettere in evidenza come operando e variando
il raggruppamento delle quantità della somma è possibile combinare in modi
differenti i termini di un problema ed ottenere lo stesso risultato. Questa
libertà creativa, ammessa in una certa misura nei sistemi formali attuali, è
ampiamente esclusa dalla logica aristotelica, perché il rapporto logico non è
un rapporto di combinazione puro come è questo svolto con i numeri, ma è
l’esito di una struttura concettuale e linguistica che precede e condiziona la
stessa costruzione del rapporto logico. È il limite originario imposto dal
razionalismo parmenideo e dall’unità linguistica che sussiste con le strutture
fondamentali della realtà. Ciò attesta un evidente limite proprio dei sistemi
assertivi ed un potere insufficiente di descrizione di tutta la logica classica,
almeno fino a quando rimane legata alla realtà del linguaggio.
Il noto quadrato di opposizione di Aristotele è appunto, uno schema
algoritmico, per così dire, con il quale non solo mettere in relazione gli
asserti universali con gli asserti particolari, cioè passare dal piano generalissimo
dell’astrazione a quello più specifico dei casi particolari, ma anche di
descrivere come e dove possa scaturire la contraddizione nel costrutto sillogistico
e quindi, porvi rimedio, risoluzione, vale a dire eliminarla. Ora, il quadrato
di opposizione di Aristotele descrive uno spazio logico, meglio prova a farlo,
e ricorda nella sua idea generale una classe di oggetti, oggi diremmo
matematici, dove il quadrato descrive uno spazio logico entro il quale permutano,
cioè cambiano, alcuni valori numerici, detti “quadrati magici”. La storia di
questi oggetti è molto antica, ma per alcuni secoli questi oggetti sono stati dimenticati
per tornare nuovamente di interesse proprio nel secolo in cui gli studi logici
decretano la crisi e la fine del sillogismo aristotelico. Oggi, questi oggetti
compongono un diffuso passatempo enigmistico e qualche anno fa anche un sorprendente
successo editoriale, rappresentato dal gioco del Sudoku, a sua volta importato dal Giappone, ma questi schemi erano
anche presenti in Occidente, seppur la testimonianza più antica di “quadrato
magico” risale al I secolo d.C. e riportata da un filosofo cinese. Pertanto,
dicevo che la logica aristotelica non ha nulla a che vedere con questa classe
di oggetti, tuttavia suggerisce un tema che la logica proposizionale
aristotelica non affrontava in modo efficace e che riguarda la combinazione.

I quadrati magici possono
intendersi de facto, in vere e proprie matrici numeriche, dove i valori
numerici si trovano incasellati in una struttura dove i loro rapporti logici risultano
costanti. Infatti, vengono detti “magici”, perché nelle operazioni che si
possono svolgere ricorre costantemente un certo valore e ciò li rende perfetti
per alcuni spettacoli di magia dove si sfruttano alcune proprietà ricorsive dei
numeri. Un esempio è il il seguente quadrato tratto dal libro di Rob Eastaway, Quanti
calzini fanno un paio? (2008: ed.it. 2009)
Questo quadrato può dirsi
“quadrato magico” perché se si sommano i numeri inseriti nella griglia si
ottiene lo stesso risultato (verificare per credere). Nello specifico questo
quadrato è quello che nella cultura cinese è il Lo Shu, che appunto la prima testimonianza storica di questi
oggetti e che in Cina fungono addirittura da amuleti. Esistono diversi modi per
costruire un quadrato magico, nel caso qui descritto si è tenuto in conto di
tenere costante il valore delle diverse somme realizzabili seguendo le varie
direzioni del quadrato, ma vi sono altri metodi di composizione, alcuni
semplici, altri un poco più complicati.
La permutazione costante
esibita da un siffatto oggetto da un lato è in accordo con la visione che gli
antichi greci, in particolare i matematici pitagorici, avevano della realtà,
vale a dire l’esistenza di un ordine armonico costante, da cui è derivata l’idea
europea di meccanicismo e di determinismo, dall’altro lato rivela l’assoluta
insufficienza degli strumenti teorici matematici dell’epoca antica, perché
questo tipo di costruzione ammette o comunque può presupporre che possa
intervenire il noto concetto di proporzionalità nel legame logico, il che è
vero almeno fino a quando si rimane nell’ambito dei numeri interi e la teoria
matematica europea per molti secoli si è mossa dentro questo scenario; ma un
siffatto quadrato può costruirsi nel modo proposto da Martin Gardner in Enigmi
e giochi matematici (Gardner: 1959, 1961; ed. it. 2014)
|
16
+ ¼
|
18
+ ¼
|
15
+ ¼
|
17
+ ¼
|
|
8
+ ¼
|
10
+ ¼
|
7
+ ¼
|
9
+ ¼
|
|
4
+ ¼
|
6
+ ¼
|
3
+ ¼
|
5
+ ¼
|
|
12
+ ¼
|
14
+ ¼
|
11
+ ¼
|
13
+ 1/4
|
È un quadrato dove le somme
producono alla fine sempre il valore di 43.

In conclusione, l’arte del
Novecento, in particolare la pittura del russo Vasilij Kandinskij, ha fatto uso
delle figure per definire un linguaggio antifgurativo che ha prodotto sì un
rinnovamento della ricerca stilistica, ma anche inesorabilmente devastato la
tradizione figurativa che dal Rinascimento in poi aveva definito un certo
canone espressivo, oggi, mi pare, incomprensibile nel modo di intendere la
creatività artistica e l’arte in generale, in ogni caso la teoria dell’arte
moderna e l’antifigurativismo che ad esso si è ispirato assegna alle figure un
significato cognitivo che non appartiene a quello elaborato in origine, ma che
a suo modo rivela la grande versatilità delle forme geometriche anche dentro
strutture narrative estranei al computo geometrico e soprattutto propongono (ed
in alcuni casi, ripropongono) un’idea di razionalità astratta molto seriosa,
avulsa dal piano della percezione comune, che è in fondo, l’idea espressa
proprio dalla filosofia e dalla logica di Aristotele. Tuttavia, per quanto
possano apparire astratte alcune costruzioni matematiche sono molto più
intuitive di quel che si possa credere, molto più del presunto determinismo
linguistico sopra descritto. In tal senso, l’intuizione kandinskijana di
ricorrere alle forme geometriche come modulo espressivo coglie, seppur in
maniera esteriore, quella semplicità intuitiva e quella chiarezza universale
che nessun linguaggio verbale per quanto ben attrezzato sembra possedere.
Post Scriptum: Mi rendo conto
che è estremamente sorprendente, almeno per me, come mi trovo in molti casi ad
avere una comprensione chiara ed inequivocabile se leggo qualcosa del tipo 2 +
2 = 4, anziché testi come il seguente <Per poter essere fondate,
proposizioni e dichiarazioni morali devono avere un contenuto cognitivo. E per
capire quale sia il contenuto cognitivo della morale dobbiamo chiederci che
cosa significhi “fondare moralmente” qualcosa. Si badi però a distinguere il
piano della teoria morale – ossia la questione se le dichiarazioni morali
esprimano un sapere e se di conseguenza siano fondabili – dal piano della
descrizione fenomenologica, ossia dal capire quale contenuto cognitivo associno
a queste dichiarazioni coloro che sono direttamente coinvolti in conflitti di
questo tipo. Comincerò a trattare la “fondazione morale” in termini descrittivi,
riferendomi alla rudimentale prassi fondativa che ha luogo nelle interazioni
quotidiane del mondo-di-vita.> (Jurgen Habermas, Una considerazione genealogica sul contenuto cognitivo della morale
in L’inclusione
dell’altro, 1996). Sono diventato veramente pigro.