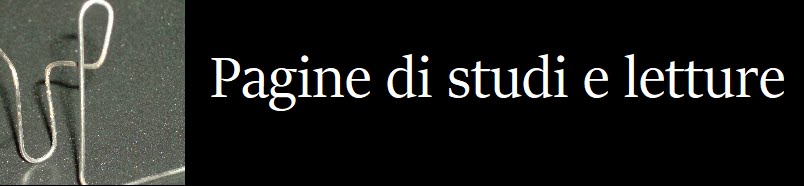sabato 16 maggio 2020
Ambiente acquatico: ruolo e funzione nel ritratto fotografico. Piccola grammatica fotografica
mercoledì 6 maggio 2020
Arresto o svolta? Considerazioni sparse sul sistema economico e sul suo futuro
#Economia,
#Lockdown, #Fabio Tamburini, #Sole24Ore, #Pandemia, #Globalizzazione
La
storia dell’economia è costellata di crisi finanziarie e da modificazioni dei
sistemi economici, indotte come conseguenza di crolli monetari o finanziari, in
ogni caso come effetti di inattese o spregiudicate azioni in sede
esclusivamente economica. La vicenda attuale di un Lockdown ad estensione
globale è apparentemente una anomalia rispetto a questa storia, non solo perché
è un provvedimento squisitamente anti-economico che scaturisce come effetto di
una pandemia virale, ma anche perché innesca delle trasformazioni economiche
del tutto inattese – in questo caso fallimenti o ristrutturazioni aziendali
devono intendersi appunto come momenti di questa generalizzata modificazione ed
alterazione della situazione economica. Il Lockdown mondiale dunque, appare
sempre più sia nel sistema della comunicazione sia nelle scelte dei governi
nazionali un fatto inoppugnabile che rovescia l’«ordine mondiale» fino adesso
conosciuto e scardinato a sua volta da molte e variegate spinte deglobalizzanti.
Spinte beninteso, che non si originano come esiti esclusivi della pandemia, ma
che agiscono in concomitanza con l’evento virale, rinforzando quella tendenza
già in atto da alcuni anni che appare ineludibilmente «la fine di un mondo».
In
tal senso, l’iniziativa editoriale del quotidiano finanziario milanese Il Sole
24 Ore appare più che la cronaca o il resoconto degli effetti economici della
pandemia, il tentativo di fornire il quadro tematico di una serie di questioni
che l’emergenza sanitaria rivela con drammaticità (es. le ripercussioni
occupazionali di una quasi del tutto annunciata recessione mondiale) o che
presenta ineditamente nel panorama intellettuale e nelle scelte che i governi
nazionali devono realizzare nei prossimi mesi, indipendentemente dal modo e quando finirà detta emergenza. Il libro del quotidiano milanese dal titolo #Lockdown. Il giorno dopo[i] fa parte di una collana di libri
prodotti dal medesimo quotidiano ed incentrata sul fornire spunti e strumenti
di riflessione, ovviamente sul piano economico, di una serie di temi che si
sono affacciati nel corso di questi anni e la vicenda relativa al Covid-19 non
poteva sfuggire ad un eventuale interessamento da parte della redazione de Il
Sole 24 Ore. Il libro raccoglie una serie di interventi apparsi tra le pagine
del quotidiano, divenendo in tal senso la piattaforma di un dialogo tra diverse
personalità della cultura economica e protagonisti del sistema economico
nazionale tutti più o meno coinvolti dal tema. I contributi sono diversi e
tutti mettono in evidenza singoli aspetti collegati alla pandemia ed ad un
tempo cercano di essere un contributo orientato a fornire una soluzione al tema
stesso o che è emerso più o meno in modo evidente nel dibattito nazionale.
L’esposizione si articola lungo tre sezioni, a loro volta indicate dalla prefazione di Fabio Tamburini, che compongono tre generiche aree tematiche:
- lo scenario internazionale entro cui si colloca il lockdown;
- le conseguenze interne nelle scelte di programmazione nazionale del governo;
- infine, gli esiti tecnologici che derivano dalla stessa emergenza sanitaria.
Come
si evince, l’interesse della pubblicazione de Il Sole 24 Ore non è l’emergenza
sanitaria in sé, né gli effetti disastrosi che questa ha prodotto nel sistema
economico e nell’ordine commerciale mondiale, quanto invece il nuovo scenario
che a causa della pandemia viene via via configurandosi, scenario che non è
necessariamente il paesaggio del futuro, ma che risulta essere una possibilità
non evitabile possibile, in quanto già preconizzato in molte strutture del
presente, in atteggiamenti e scelte che caratterizzano la società attuale, nella
vita pubblica odierna.
Ciò
detto, questo intervento non è un commento o un’analisi della pubblicazione,
che al momento sto ancora leggendo, ma è essenzialmente un fare il punto o
semplicemente un voler trarre qualche considerazione anche se collocate
trasversalmente entro uno scenario comune a molti temi e a molte questioni.
Tenendo come riferimento o traccia tematica la stessa prefazione di Tamburini, ravviso i seguenti punti:
- Di crisi economiche globali ne abbiamo viste alcune, la più recente è quella nota del 2008 causata dal fallimento di un istituto bancario statunitense (Leehman Brothers Co.), che ha fatto scoppiare il caso delle contrattualità subprime, che agli inizi degli anni 2000 erano divenuti vantaggiosissimi strumenti finanziari in quanto permettevano di speculare sul mercato sgravando gli agenti dai rischi finanziari che venivano in capo ai vari debiti nazionali: il fallimento della banca statunitense inceppa il meccanismo e da questo deriva quella gigantesca bolla finanziaria da cui deriva una recessione globale che durerà fino al 2012-2015, regolata dall’intervento dei governi nazionali e dalle banche centrali che impongono alcuni strumenti di capitalizzazione che assicurassero stabilità. Lo scenario insomma, è quello di un sistema economico sempre più avvinghiato dalle restrizioni legislative che rappresenta un cambio di rotta rispetto alle politiche degli anni Ottanta del secolo scorso incentrate sulla deregolamentazione o liberalizzazione (come impropriamente vennero indicate in Italia, ma in questo caso siamo verso la fine degli anni Novanta). Ciò detto, quando gli autori della pubblicazione de Il Sole 24 Ore dicono concordemente che una delle conseguenze più evidenti dell’emergenza sanitaria è la messa in crisi del sistema del mondo globale affermano una situazione che è già un dato di fatto indipendentemente dall’emergenza sanitaria. Che il modello della Globalizzazione sia entrato crisi ciò è certamente vero e evidente adesso, ma sono da alcuni anni che esistono nel panorama internazionale situazioni e spinte deglobalizzanti, le quali traggono dall’emergenza sanitaria la loro fondamentale occasione per dare se non una spallata definitiva al “vecchio ordine mondiale”, almeno assestare un grave colpo da loro ritenuto irreversibile. I vari sovranismi che hanno tenuto banco nel dibattito politico internazionale e che ha condizionato anche le scelte elettorali nazionali ed internazionali si muovono in uno scenario caotico, anche da loro stessi rimestato, che però si limita a creare incertezza, poiché da questa caoticità non è ancora chiaro che tipo di sovranità dovrebbe scaturire, soprattutto se questa riconquista sovrana passa attraverso una richiesta di maggiore autonomia ed emancipazione dalle istituzioni centrali. Lo stato emergenziale indotto dalla pandemia introduce un fatto politico ed economico non del tutto irrilevante, almeno per chi imposta i propri slogan politici su temi come deburocratizzazione o come un tempo si diceva “federalismo” o “autonomia”, e cioè il rafforzamento proprio del potere centrale e di alcuni istituti nazionali e sovranazionali che in questi anni sono stati oggetto di una campagna denigratoria diffusa nei confronti politici nazionali ed europei. Non siamo alla fine dell’ordine della Globalizzazione (vecchio mondo), di certo ci si è da tempo incamminati verso questo direzione, anche perché a cedere le armi non è tanto e solo il modello globalistico, quanto una certa narrazione della stessa Globalizzazione, sicuramente quella definita proprio negli anni Novanta del secolo scorso: ci si dimentica che la Globalizzazione nasce per tentare di diversificare l’intero ordine economico mondiale incentrato su un modello economico-finanziario ancora restìo ad integrare entro le proprie strutture alcune pezzi di produzione e di sviluppo che erano rimasti ai margini dopo la svolta dell’economia mista, svolta che ne aveva dovuto garantire spazio ed una maggiore rilevanza. In realtà, tutto il sistema economico mondiale rimane legato ai convenzionali asset economici (petrolio, oro, diamanti, …) ed il sistema stesso del commercio mondiale ha ancora una struttura troppo affine a formule come il Commonwealth britannico o comunque, all’egemonie finanziarie delle grandi compagnie: la fine del regime del tasso fisso, scelta operata arbitrariamente dall’amministrazione Nixon, ha rimescolato una situazione che in ogni caso, seppur con difficoltà, ha tratto giovamento in alcuni settori dalla libertà dal dollaro – senza questo tipo di autonomia monetaria non è minimamente pensabile, né realizzabile un progetto come l’unificazione monetaria europea nella Zona Euro. In ogni caso, comunque la si pensi la fluttuazione dei mercati, quella stessa che ha permesso la definizione dell’economia cartolarizzata, ha costretto un’evoluzione del sistema economico in direzione di una maggiore libertà economica, ma anche una minore tutela da parte degli istituti nazionali, ai quali si avanzavano ben altre richieste che non quelle di occupare lo spazio economico di competenza del capitale privato. La Globalizzazione, ad un certo punto, si aggancia a questo spazio avuto tramite la deregolamentazione e sfruttando le potenzialità di alcuni settori economici (es. i trasporti, il turismo, l’import e l’export di beni che non fossero solo gli asset economici, …), ma assumendo al contempo un profilo non facilmente statuito, cioè la Globalizzazione incarna alla fine il vecchio ideale liberale di un’economia capitalistica di tipo liberista ed a tratti ottocentesca, ma entro un regime economico che è quello di un’economia dello welfare state. Gli sforzi di molti governi nazionali, anche di quelli non sospetti di tentazioni statalistiche e burocratizzanti, sono costretti a rivedere il sistema delle tutele economiche in un’ottica centralista, in quanto alcuni settori della vita sociale non possono essere più lasciati al loro destino (es. la previdenza sanitaria). Non deve pertanto, sorprendere che la crisi del modello globalista passi attraverso e con l’emergenza sanitaria, perché la salute pubblica così come la percezione di un reddito individuale (soprattutto in certi contesti economici) diventano temi sensibili, in quanto sotto attacco proprio dalla stessa emergenza sanitaria: la Globalizzazione ha operato e si è imposta non solo perché attraverso di essa viaggiava il grande capitale finanziario, ma perché ha lasciato sguarnita una qualsivoglia difesa di questi due aspetti della vita materiale delle persone, non prevedendo alcun sistema di tutele che per definizione sono in capo ai poteri centrali.
- La realizzazione dell’ideale di una collaborazione internazionale (cooperazione) affermatosi come valore civile e come criterio politico-diplomatico dopo la Seconda Guerra Mondiale ha configurato una piattaforma ideale ed un sistema politico vero e proprio tramite lo strumento delle organizzazioni internazionali su cui a lungo andare è venuta ad appoggiarsi la stessa Globalizzazione. Ridurre le distanze che esistevano con le varie regioni periferiche del mondo era una mission politica, ma anche una stretta necessità economica, espressa da problematiche complesse e strutturali quali la fame nel mondo, le emergenze sanitarie e le migrazioni forzate. Problematiche che producevano alcuni chiari riflessi nella vita politica e sociale dei paesi più ricchi e progrediti socio-politicamente, per cui la via di un mondo sempre più in relazione con le sue parti, con quelle regioni lontane sembrava la soluzione a molti di questi problemi. Assunzione parzialmente vera, ma che si scontra in modo deludente con una serie di limiti strutturali nei vari programmi internazionali e nella stessa logica economica alla base di questa stessa attività internazionale: il sistema economico che utilizzano non è un sistema globale, ma è un sistema che ha differenziato le regioni del mondo in regioni produttori, in regioni trasformatrici e in regioni accumulatrici. Questa differenziazioni fittizia o effettiva che sia permette la produzione di un reddito mondiale che viene distribuito secondo quote fissate dal potere delle nazioni più forti o verso le quali c’è una decisa attrazione di ricchezza: lo svuotamento di molte aree del pianeta è anche effetto di questa direzionalità della ricchezza. L’idea ammessa a livello internazionale negli anni Settanta è quella di risarcire in qualche modo queste regione depauperate e ricompensarle tramite una limitata ridistribuzione di piccole quote di questo reddito mondiale sotto forma di aiuto umanitario, ma la via intrapresa non ha risolto i problemi cronici delle aree depresse del pianeta e sotto vari aggiustamenti si è tentato di creare poli economici in quelle aree in modo da creare un circuito economico che potesse interagire con il sistema del libero mercato. In tal senso, entra in gioco il bistrattato modello della Globalizzazione che permette a queste aree di collocare se stesse e la propria attività produttiva entro un sistema sovranazionale regolato dal sistema del diritto internazionale e dalle regole di commercio tra le nazioni. Uno scenario che definisce l’idea stessa di sovranità ad un livello differente da quello della tradizionale narrazione ideologica e che si fonda su un sistema di valori immateriali e culturali che non è quello convenzionale e che non è quello su cui si appoggia l’ordine economico tradizionale, la stessa legislazione del lavoro e il sistema ideologico della politica attuale. Pertanto, in questo scenario fatto di un mondo che piaccia o che non piaccia è (ed è rimasto) globale l’emergenza sanitaria rivela alcune evidenti ipocrisie concettuali soprattutto in soggetti che per varie ragioni (storiche, politiche, economiche, …) non hanno definito una struttura che sciogliesse il dilemma alla base tra il vecchio sistema della sovranità liberale ottocentesco e la nuova dimensione internazionale di una sovranità che non ha più basi territoriali o identità etnico-popolari, ma ha una base immateriale determinata dalla sua inscrizione ad una storia di civiltà a cui non appartiene necessariamente (cfr. popoli del deserto o gli esquimesi), ma di cui è costretta a farne parte per ragioni contingenti e non storici. A tal riguardo, un aspetto evidenziato da Tamburini, ma dagli altri autori del libro, è l’interrogativo relativo allo ideale dei Padri fondatori della Comunità Europea; interrogativo legittimo, a mio avviso, ma fino ad un certo punto. Ammesso e non concesso che l’ideale di cui si sta dicendo sia rappresentato dall’Europa di oggi al netto di tutte le distinzioni che si possono fare in un dibattito a tema, è pur vero che nella sua fase di costruzione che parte proprio da quell’ideale fino alla coniazione della moneta unica è venuta a mancare quello sforzo decisivo che trasformasse ciò che era un ideale in un soggetto politico vero e proprio, voglio dire un soggetto che avesse ben chiaro cosa fosse la propria sovranità e come poterla esprimere ed affermare in ogni momento della propria vita politica e sociale, oltre che economica. La verità inoppugnabile è che il soggetto di oggi, quello che chiamiamo Europa o alternativamente Zona Euro, è un soggetto che ha tentato di definire strutture che a conti fatti risultano manchevoli non solo e non tanto perché non esistono (vedasi una vera unitarietà bancaria raggiunta solo da qualche anno), ma perché rispondenti ad un modello di riferimento che andava bene fino a qualche anno fa; adesso la via indicata dalle stesse spinte deglobalizzanti e sovraniste, paradossalmente, esprimono una richiesta più attuale delle soluzioni che le istituzioni europee e qualche governo nazionale vuole proporre, anche se beninteso, non sono poi così convinto che le direzioni indicate da queste forze siano giuste o adeguate alle sfide degli anni futuri. In ogni caso, interrogarsi sulla validità di un’ideale come è la Europa unita (politicamente ed economicamente, oltre che culturalmente) è solo rimuginare su un tema che non esiste o che è meno rilevante di quel che si creda, soprattutto se la lezione che si ha di fronte è quella di alcune sovranità che operano e che esercitano (e fanno sentire) il loro peso politico esclusivamente sul piano internazionale, perché i propri sistemi economici sono già collocati sul piano internazionale (es. il programma cinese de “la via della seta”). In questo scenario non credo che abbia tanto senso un dibattito sulla sovranità europea, sul fatto se sia messo in crisi il suo ideale e via dicendo quando la fase attuale dimostra come il destino dell’Europa è quello di soccombere alle trasformazioni politiche e sociali in atto nelle aree limitrofe, trasformazioni funzionali alle modificazioni economiche.
- La fine della Globalizzazione auspicata, elaborata e realizzata da molti fronti ideologici, politici e sociali và di pari passo, come detto, con la fine del vecchio ordine economico, quello stesso ordine che i suoi detrattori accusavano di aver concentrato la ricchezza mondiale «in poche mani» o di aver incancrenito come fenomeni strutturali alcune situazioni che un tempo si ritenevano transitorie (es. povertà assoluta), o di aver precarizzato i rapporti di lavoro e con essi di aver abbassato i redditi da lavoro, per non dimenticare il tema della dislocazione produttiva e via dicendo: poco importa se ciò è stato effetto più del “turbocapitalismo” che non della Globalizzazione in senso lato e poco importa (e invece dovrebbe) se la messa in crisi della stessa Globalizzazione non apre (e non li aprirà) scenari di giustizia sociale e di benessere economico senza un dichiarato ed esplicito intervento legislativo che attenui le stesse contraddizioni del sistema economico. Certo, alcuni temi sono diventati (ahinoi) strutturali (cfr. inquinamento e cambiamenti climatici), tanto da guardare con inquietudine il futuro, non solo per una serie di croniche incertezze date dall’instabilità stessa della situazione economica, ma anche perché la integrazione sempre più sistemica tra economia e politica non è un fattore rasserenante. L’esito più inquietante prodotto dall’emergenza sanitaria è appunto, con buona pace dei vari critici degli apparati burocratici, proprio una richiesta (spesso isterica) di intervento dello stato da parte della comunità con la finalità di rimediare laddove gli automatismi (semmai fossero realmente esistiti) dell’economia non riescono a dare risultati soddisfacenti. Il baratto, ormai esplicitato ed umoralmente accettato, che si sta compiendo (e si è già compiuto) per avere uno straccio di sicurezza economica e sociale (anche fittizia) a danno del sistema dei diritti, trova conferma certamente a partire dal tema della sovranità, ma trova effettiva realizzazione non tanto a questo livello di collettività, quanto su quello delle stesse relazioni interpersonali. Nel suo intervento su Il Sole 24 Ore del 15 febbraio, Donato Masciandaro indica che la stessa emergenza sanitaria ha costretto le banche centrali a tenere un differente atteggiamento verso la eventuale formulazione di una politica monetaria, in quanto i governatori ravvisano come questa stessa non possa rappresentare la sola soluzione alle richieste attivate dall’epidemia. Questo perché l’epidemia agisce sugli stessi fattori moltiplicatori su cui la politica monetaria di questi anni ha agito ed utilizzato, cioè quei moltiplicatori derivanti dalle reti interpersonali di clienti e soci: l’epidemia colpisce questo tipo di strutture che non hanno nulla a che vedere con la “sovranità nazionale”, ma possono condizionarne altresì la stessa natura. La confusione del dibattito in questi giorni rivela su questi temi in buona sostanza un certo condizionamento ideologico e una certa pregiudizialità culturale e forse anche politica, in ogni caso la tendenza di questo dibattito rivela da un lato la conferma di una sempre più esplicita richiesta proveniente dalle stesse opinioni pubbliche di una maggiore concentrazione del potere, magari barattando la configurazione di un potere centrale con il sistema di diritti acquisiti, già ampiamente compromesso dall’urgenza sanitaria, dall’altro lato queste politiche di emergenza, per quanto giustificate all’apparenza, sviliscono e depotenziano quegli strumenti che a fatica il sistema sociale si è dotato per contrastare efficacemente proprio questa deriva centralistica e monopolistica tipica dei poteri istituzionali (soprattutto in certi settori ritenuti particolarmente sensibili, es. l’ordine pubblico), dove l’equilibrio tra la libertà individuale e quella collettiva è sempre una distanza che deve determinarsi all’uopo, di volta in volta, contingentemente: l’emergenza sanitaria non permette alcuna forma di contrattazione sugli spazi di libertà veri o presunti su cui è possibile agire individualmente o collettivamente; a tal riguardo, la paura è un motivo di allarme giustificabile, l’ipocondria certamente no.
Per
concludere, la tesi di fondo della pubblicazione de Il Sole 24 Ore e che la
prefazione di Tamburini dà evidenza è che per quante varie possano essere le
conseguenze innescate dall’emergenza sanitaria e soprattutto dal lockdown
imposto dal decreto governativo è altrettanto evidente che non ci si può più
rivolgere alle varie politiche monetarie e alle altrettante soluzioni di
capitalizzazione finanziaria viste in questi anni (basti pensare al “bazooka”
formulato da Mario Draghi durante la sua presidenza) e che forse sia arrivato
il momento (chissà quante volte lo abbiamo sentito dire) di formulare e di
iniziare ad applicare «un nuovo modello di economia e società, nuove strategie
industriali, nuove visioni del mondo».
Post
Scriptum. Ammetto che ho cominciato a selezionare parole, concetti e financo
idee non tanto per comporre un lessico con cui esibire la mia raffinata (o
dozzinale) proprietà di linguaggio, ma un lessico di ciò che trovo
insopportabile, vuoi perché intellettualmente obsoleto, vuoi perché
semplicemente insopportabile. In questo nuovo lessico inserisco con grande
piacere la parola “responsabile” con il suo plurale, cioè “responsabili”, che
nella comunicazione ordinaria, soprattutto in quella politica, è diventato un
concetto a sé di cui fregiarsi e che esercita grande fascino (forse in chi lo
enuncia!). In questi giorni di restrizioni il richiamo alla responsabilità
personale, di gruppo, di partito, di collettività, di società, di patria e via
dicendo si è sprecato e se fosse una salsa credo pure che l’avremmo visto
utilizzato come condimento in qualche primo piatto a pranzo. Ecco, a furia di
sentirlo dire a questo e a quello, in bocca di quel capo politco o in bocca di
quel simpatizzante o critico che mi è venuta una reazione allergica. Vorrei
tanto che qualcuno di costoro che si sentono delle anime responsabili mi
spiegassero che cosa vogliono dire con il loro essere “responsabile”, perché se
penso alla mia vita, le cose che ricordo con grande piacere ed interesse sono
proprio quelle situazioni e quelle vicende in cui tanto responsabile non sono
stato; e nonostante il paradosso, quando mi è accaduto di essere sconsiderato
ho appreso i migliori insegnamenti che potessi ricevere dalla vita e dagli
uomini. In tal senso, vale ancora la splendida sottolineatura di Umberto Eco
sulla figura di Franti del noto libro di De Amicis, ma vale anche la sagace
ironia dandy di Oscar Wilde quando intitolava una delle sue gustose e
divertenti commedie (una di quelle che preferisco!) nel seguente modo “L’importanza
di chiamarsi Ernesto”, peccato che la stessa traduzione italiana del titolo non
permette immediatamente di cogliere l’ironia esplicita contenuta nel titolo wildeiano,
perché altrimenti tutti questi responsabili sia quelli di prima che dell’ultima
ora se ne guarderebbero dal definirsi tali. Ed infatti, per quanto mi sia
concesso dalla vita e dalle vicende quotidiane, spero tanto e mi sforzo di non
essere responsabile, neanche della mia stessa storia (vero factum est).
[i] Piccola Biblioteca del Sole 24 Ore, #Lockdown. Il giorno dopo, 2020 Il Sole 24 Ore S.p.A., Milano.