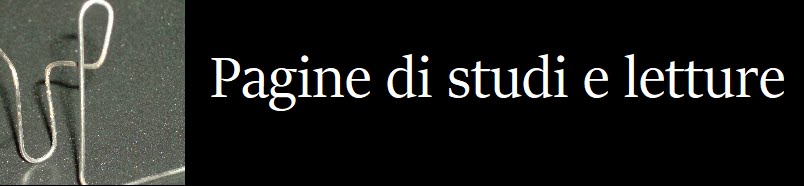#GustavKlimt, #EgonSchiele,
#Arte, #StruttureNarrative, #Erotismo, #GeorgesBataille, #Proibizioni,
#Divieto, #Tabù, #Ritratti, #NudoFemminile, #NudoMaschile
Ammetto che quanto segue
prende spunto da uno speciale proposto dalle reti Mediaset, che non ho visto e
che per ovvie ragioni evito di commentare, tuttavia il titolo dello speciale, Eros e Psyche, suggerisce le coordinate
sulle quali viene impostato il racconto dell’amicizia e della co-militanza
artistica tra due dei maggiori esponenti della pittura austriaca di prima metà
Novecento, cioè Gustav Klimt e Egon Schiele, fondatori della Secessione
austriaca del 1907. In questo caso (presumo), l’erotismo è il registro (non
l’unico a quanto pare) con il quale si tenta di descrivere questo rapporto e
delineare al contempo una lettura sinottica dell’opera dei due artisti, ma che
ha un suo preciso limite e inizio temporale, verosimilmente a partire dal 1907,
anno in cui Klimt entra in contatto con vari esponenti della avanguardia
espressionista austriaca tra cui appunto, Schiele, che si fa notare
dall’artista più anziano durante la frequentazione di questi alle attività
della Accademia di Belle Arti di Vienna e di cui diventerà in seguito amico.
Una storia di amicizia dunque, ma non solo visto che è proprio a partire da
quell’anno che Klimt si accosta più decisamente alle soluzioni
espressionistiche e di cui accoglie le urgenze espressive, come rivelano alcuni
ritratti femminili di questa fase (Fritza
Riedler, 1906 e Adele Bloch-Bauer,
1907 entrambi conservati presso la Galleria Osterreichische) e che fanno di
Klimt un vero “intermediario” (Eisler [1931]) della direzione dell’arte
figurativa austriaca nel primo Novecento.
È vero che il tema erotico, in
particolare il ritratto di figure femminili, è comune in molte opere dei due
artisti, in Klimt addirittura è una costante tematica, tuttavia è evidente che
l’erotismo descritto dai due pittori non è il medesimo, e ciò non solo a causa
della difformità di stile. L’erotismo è un tema ricorrente nell’arte europea,
ma è pur vero anche che la stessa storia dell’arte figurativa presenta svariate
e sovente difformi rappresentazioni dell’erotismo, anche tra artisti che
operano nella stessa stagione artistica. In tal senso, i due artisti non fanno
eccezione, semmai viene da chiedersi tutt’altro, e cioè quanto l’arte
figurativa possa dirsi realmente lo strumento privilegiato con cui raccontare e
descrivere l’erotismo – ovviamente oggi ne esistono tanti altri compresa la
virtualità tridimensionale. In questo caso, quanto la soluzione figurativa proposta
da questi due artisti possa raccogliere realmente la portata trasgressiva e
deviante che la sessualità esprime sia in termini di immaginario, sia in
termini di appagamento anche feticistico-voyeuristico. Il nudo femminile (e in
misura più limitata il nudo maschile) mantiene, indipendentemente dallo
strumento espressivo (pittura, fotografia, scultura, …), una cifra
profondamente correlata allo stile, alla forma artistica, negando in questo
modo il suo essere predeterminato: l’erotismo ha a che vedere sì, con
l’esibizione del corpo, ma non si limita e non si compie esclusivamente su
questo.
Klimt e Schiele sono una delle
tante apoteosi di questo modo di intendere e raffigurare l’erotismo, ma ciò non
vuol dire che essi trovano nell’erotismo la cifra qualificante della loro
pittura. Il nudo e la sensualità sono solo dei pretesti, dei soggetti
qualsiasi, come può essere una cesta di frutta o un paesaggio, anche se c’è da
dire che il ritratto eseguito si carica di significati che proprio la
creatività estetica e la sensibilità artistica individuano e fissano in
quell’immagine prodotta. Creatività e intuizione certo, ma l’erotismo è un tema
che per quanto lo si possa considerare autoreferenziale ha una sua
convenzionalità che gli deriva dalla storia, dalla forma e dalla tradizione
censoria. Ecco perché in una certa misura la pittura erotica è l’immagine di
una stereotipia che si è storicizzata sotto forma di “narrazione”, ma è anche
il momento stilistico che non si lascia assorbire totalmente e integralmente da
suddetta costruzione.
È il tema che può ritrovarsi
in questa relazione artistica.
Il tema erotico è forse uno
dei temi che più di altri rivela la collocazione “attuale” dell’opera d’arte
nel suo presente, ma anche nel presente di altre epoche, tanto che la categoria
erotica definisce un proprio spazio di posterità che la inserisce nella storia
e nella stereotipia dell’immaginario di una civiltà, nel suo sistema della
comunicazione ordinaria. Basti pensare a La
nascita di Venere di Sandro Botticelli, un’opera che ognuno di noi
percepisce come assoluta, come fuori dal tempo, eppure rappresenta un’idea di
erotismo che ci appartiene molto labilmente; oggi continuiamo ad accettare
questa forma di erotismo come modello culturale, perché è la civiltà
rinascimentale ci appartiene, è un momento della storia europea e ha
contribuito a comporre il significato della fase attuale. Un’assimilazione che
riguarda sì, gli eventi della storia, ma anche le forme di arte, le quali
codificano in sistemi ideali e concettuali tradizione e memoria (es. il
naturalismo figurativo), comunicazione culturale-ideologica (es. arte pubblica),
e che costituiscono a loro volta una precisa direzione sulla quale indirizzarsi
nella costruzione degli immaginari, almeno fino al definirsi della prossima rivolta
di tipo neodadaista o simile. In sostanza, l’erotismo è esso stesso (o è
diventato) una struttura narrativa, per cui interrogarsi sulla relazione tra
Klimt e Schiele tramite questo registro significa non essere del tutto sicuri
di non rimanere avvinti da questa narrazione, fosse anche di natura
archetipale.
Ma la pittura può rimanere
immune da questo condizionamento? Definiamo un contesto e una prospettiva.
L’erotismo non è solo una
rappresentazione di corpi nudi, ma è il tentativo irrisolto (e forse
irrisolvibile) di cogliere quello “spossessamento” (Bataille) che l’esistenza
ed il divenire storico opera sulle umane possibilità temporali. L’erotismo non
è una immagine, ma, per così dire, il symbolon
di questa incapacità strutturale dell’uomo di dare definizione materiale al “poter-essere”
delle cose, di illudersi di poter fermare il tempo e di fissare al contempo una
realtà assoluta che possa essere riprodotta all’infinito.
Una visione che è di per sé una trasfigurazione metafisica della sensibilità, potente
certo e instabile, ma che ammette necessariamente una costruzione ed un ordine
che sono estranei al piano dell’immediatezza dei sensi. La nota definizione data
dal saggista francese Georges Bataille nell’introduzione de L’erotismo (1957), opera pubblicata postuma
nel 1961, fissa il seguente concetto,
“Dell’erotismo si può dire che
è l’approvazione della vita fin dentro la morte. In verità questa non è una
definizione, ma ritengo che una simile formula possa dare più di ogni altra il
senso preciso dell’erotismo. Se fosse richiesta una definizione esatta,
bisognerebbe senza dubbio risalire all’attività sessuale di riproduzione, di cui
l’erotismo è una forma particolare. L’attività sessuale di riproduzione è
comune agli animali sessuati come l’uomo, ma, a quanto sembra, solo
quest’ultimo ha fatto della propria attività sessuale un’attività erotica; ciò
che differenzia la semplice attività sessuale dall’erotismo è una ricerca
psicologica indipendente dal fine naturale insito nella riproduzione e nella
cura dei figli”.
La concezione erotica di
questo saggista francese non può disgiungersi dalla produzione narrativa come
rivela Alexandrian nella sua Storia della
letteratura erotica [1994], ma che trova una sistemazione coerente proprio
nelle opere saggistiche. L’erotismo batailleiano rivaluta la propria
derivazione dal sistema delle proibizioni e dei tabù, che è la ragione
autentica da cui scaturisce non solo la costituzione dell’oggetto desiderato,
inteso come realtà proibita e illecita, ma anche l’affacciarsi di una morbosa
passione irrefrenabile e autodistruttiva (cfr. ib., L’abate C.). Il
desiderio erotico è la rappresentazione vitalistica dell’irriducibile polarità
tra l’etica pubblica e la sfera privata, quest’ultima spesso prevaricante su
quella in quanto derivata dall’esperienza interiore del soggetto e dal basso materialismo archetipale ed
inconscio che configura l’immaginario erotico e non solo dell’io. Un erotismo
questo batailleiano per nulla addomesticato, deviante e delirante e che elabora
un significato di follia erotica, già elaborato dagli esponenti del Surrealismo
francese e in particolare di Aragan.
Scrive Bataille in Storia di topi, raccolto in L’impossibile [1962],
“È strano che lo stesso
bagliore insensato brilli per tutti gli uomini. La nudità fa paura: la nostra
natura deriva totalmente dallo scandalo in cui la nudità ha il senso
dell’orribile… Quel che si chiama nudo
presuppone una fedeltà lacerata, non è che una risposta incerta e imbavagliata
al più torbido dei richiami. Il furtivo bagliore intravisto nell’oscurità non
richiedeva forse il dono di una vita? Ognuno, sfidando l’ipocrisia di tutti
(quanta stupidità nel fondo dei comportamenti «umani»!, non deve forse
ritrovare la via che lo conduca, attraverso le fiamme, alla sozzura, alla notte
della nudità?”
(L’impossibile, SE, p.30)
L’idea di fondo nella
prospettiva batailleiana è questo vitalismo nichilistico che risulta
refrattario ad essere assimilato e compiuto in forme esteriori che svilisce
la spontaneità e l'immediatezza, anche se queste sono e appaiono al giudizio
sociale perverse, degradanti e deliranti. Il nudo non è un concetto, ma proprio
quella apertura alla realtà metafisica della morte, come dire l’essere e
rimanere esposti (inermi) dinanzi ad uno stato ineluttabile che non è estraneo
alla dimensione dell’esistenza – la nudità è un richiamo, come lo è in fondo la
morte e che insegna l’irrilevanza delle forme esteriori e dei costrutti
pubblici. E per tale ragione la nudità è strutturalmente uno stato dell’essere
che ha in sé una cifra di trasgressione e di eversione dinanzi ai costumi,
perché li previene, li rifiuta, li sconvolge. L’esperienza erotica non può essere
né contemplazione né visione, ma è una espansione di sensibilità da cui
scaturisce l’angoscia che produce il divieto ed il desiderio che induce il
soggetto a violarlo. Una irrefrenabile inquietudine che eccita l’uomo, ma che
lo induce a distruggere al contempo la proibizione e il tabù, in quanto sono
come tutte gli altri sistemi culturali forme esteriori dell’esistenza con le
quali l’uomo definisce ed impone la propria collocazione sociale e culturale
nel mondo. Il desiderio erotico è un atto di rivolta con il quale il soggetto
configura un nuovo ordine che non è più quello pubblico, ma quello “privato” che
tende a sostituirsi a questo.
In base a questi assunti la
produzione di immagini erotiche non può ammettere una matrice sociale, non si
può ritenere che esista un erotismo che non sia irriducibile alla morale
pubblica, anche se da questa trae la propria ragion d’essere, né si può
ritenere che l’erotismo tragga la propria legittimazione da una narrazione che
la preceda e che la giustifichi pubblicamente. E ciò vale per qualsiasi
attività o produzione culturale che opera nell’esteriorizzazione di contenuti,
che magari abbiano pure la pretesa di presentarsi come forme senza tempo per
via della storia, della tradizione, dell’immaginario, del diritto, dell’arte
figurativa.
Definita in questi termini, la
questione del rapporto tra erotismo ed arte è molto più di un mero registro con
il quale rileggere due esistenze, per quanto affini e correlate tra loro da
rapporti di amicizia, ma definisce un quesito estetico di non facile soluzione
per la stessa arte figurativa novecentesca, la quale si è mossa verso soluzioni
figurative fortemente drammatizzate e verso un contesto formale e disciplinare
che non è più quello figurativo (es. il teatro con le drammatizzazioni
Happenings, Fluxus, Body Art e via dicendo). Il tema erotico è o rappresenta il
punto nodale di una questione estetica che supera il fatto che la nudità sia
un’esposizione di corpi – tema da cui non sono estranee neanche le più recenti
produzioni di immagini come la fotografia.
Ciò detto, l’erotismo espresso
dalle opere di Klimt e Schiele raccoglie perfettamente quella idea batailleiana
per la quale la nudità è già di per sé un dato scandaloso, in parte per le
ragioni profonde descritte dal saggista francese, in parte per un’ipocrisia
culturale e deficienza tipicamente occidentale, cioè la nostra incapacità di
accettare che possa esistere un piano immateriale, come è quello dell’immagine
erotica, e risultare estranea ad ogni ricollocazione schematica e ideale. A suo
modo l’arte figurativa prova a creare una narrazione sullo erotismo e se
osserviamo le realizzazioni pittoriche che lo hanno riguardato si ha
l’impressione appunto, che possa esistere una storia figurativa dell’erotismo e
quindi, una narrazione vera e propria su di essa. Il fatto è che bisogna
distinguere il piano filosofico della questione come in fondo ha fatto
Bataille, da quello estetico che riguarda rettamente la storia dell’arte. In
tal senso, l’erotismo diventa uno dei diversi registri tramite il quale
l’attività di un artista si esplica, producendo immagini che ne fissano
iconicamente anche alcune cifre decisive della propria creatività e aspetti
rilevanti della propria opera artistica, ma ciò significa che in questo caso
non sia possibile parlare di una unica categoria concettuale, bensì di tanti e
diversi erotismi quanti sono gli stili e le intuizioni creative che lo hanno
definito.
Klimt e Schiele sono un
momento di questa dimensione o storia, tra l’altro non so quanto
rappresentativo, ma che appartiene alla storia della pittura, anziché
dell’erotismo in sé. In ogni caso, l’erotismo klimtiano di sicuro ha perso
nell’evoluzione stilistica del discorso pittorico dell’artista austriaco quella
cifra scandalosa che ne aveva caratterizzato gli acuti della prima produzione. Le
figure femminili di Klimt esibiscono una sensualità immediata, non
necessariamente spontanea, che tra Ottocento e primo Novecento destavano
scandalo, più che altro per una "pruderia" sociale e pubblica, che per
una qualche sconvolgente concezione erotica. È il corpo femminile nudo a
destare scandalo e soprattutto la riconoscibilità della sua funzione biologica
legata alla riproduzione, funzione che Klimt esalta nelle due versioni di Speranza, ma connotate da un significato
che è meno urtante di quel che il perbenismo dell’epoca potesse ritenere.
L’erotismo klimtiano è in buona sostanza molto stereotipato e risponde ad una
visione molto tradizionale, che potrebbe piacere anche alla attuale cultura
cattolica, quella cioè per cui la sensualità del corpo femminile sta
essenzialmente nella sua capacità di definire il concetto di maternità: le
donne klimtiane non sono l’oggetto di una sensualità sfrenata e
autodeterminata, ma essenzialmente madri. Laddove la sensualità non può
declinarsi seguendo il registro funzionale della riproduzione materna
l’erotismo klimtiano ripropone il tema figurativo molto rassicurante di una
innocenza giovanile, trasfigurando le sue candide ninfe in sognanti ed oniriche
figure evanenscenti e per nulla corrotte o deturpate dal peccato, dal vizio,
dalla decadenza. Un esito questo molto reazionario e che si palesa proprio a
partire dai suoi contatti con le grandi figure dell’Espressionismo austriaco:
non è casuale, a mio avviso, che vi sia un ritorno da parte di Klimt dei temi
della mitologia greca, quegli stessi che lo avevano aiutato a definire
l’illusorio progetto della sua opera totale. Ma opera totale significa opera
assoluta, cioè una opera che rimanga avvinghiata all’attualità perennizzata
dalla storia e dall’immaginario ad essa correlata. I quadri a tema erotico per
acquisire questa dimensione devono formalizzarsi in una composizione
concettuale, che li rende eterei e soprattutto dislocati e sospesi in una
temporalità che non esiste e che solo la fantasia ed il sogno possono dare. Per
tale ragione, i grandi ritratti femminili di Klimt sono certamente il momento
più convincente della sua attività pittorica, perché esprimono immagini che non
sono virtuali o smaterializzate; insomma, non si collocano dentro una
preconcetta e preventiva narrazione.
Altro discorso per quanto
riguarda l’erotismo di Egon Schiele, che non ha questa cifra sognante e onirica
di Klimt. Il materialismo erotico di Schiele deriva anzitutto da un esito
stilistico. La sensibilità espressionista che Egli deriva dal gruppo espressionista lo
conducono ad avere una visione inquieta dell’esistenza che si traduce in un
disegno molto ordinato e da una cromia che abbandona i toni brillanti dello
Jugend e privilegia i contrasti cromatici: manifesto di questa fase della
pittura schieleiana è il Ritratto di
Poldi Lodzinski (1908). L’erotismo in Schiele rappresenta una conquista di
serenità espressiva, il calare di intensità di quella inquietudine che lo
divorava, tanto che i quadri a tema erotico si collocano a partire dagli anni
Dieci. Ma a differenza di Klimt che ha privilegiato sempre la figura femminile
come immagine erotica e morale, Schiele introduce una variante meno convenzionale,
il nudo maschile. Il nudo maschile rappresenta inevitabilmente un distacco
dalla usuale produzione iconografica, anzitutto per il soggetto e poi perché
risulta meno permeabile alle sovrastrutture ideologico-narrative: se la figura
femminile klimtiana può veicolare l’idea tradizionale della maternità, la
figura maschile diventa l’emblema di un paesaggio erotico attraversato da forti
contrasti, ansie e derive degradanti; un paesaggio che non ha la finalità
convenzionale dell’immagine erotica, quella cioè di essere una forma
accattivante e seducente. In tal senso, lo scandalo che suscitano i ritratti
erotici di Schiele è realmente una reazione di disagio profondo dello stesso
sistema culturale austriaco e più in generale europeo, in quanto vede nel corpo
maschile il denudarsi senza riparo e l’esposizione inerme di ansie irrisolte.
Un esempio di questo diverso
modo di intendere l’erotismo è l’autoritratto del 1910 dal titolo Nudo maschile
seduto. Autoritratto, dove si ravvisano i tratti fondamentali dell’opera di
Schiele di questo periodo. La figura del corpo non ha alcuna idealizzazione
estetica e men che mai concettuale; l’idea di concreta attualità è data dalla
figura di un corpo che esibisce la propria imperfezione stilistica, non vuole
sedurre, eppure trova nella propria nudità quella libera apertura e
naturevolezza che non ha nulla di artificiale, o di costruito. Il piano del
ritratto è quello bidimensionale e la figura lascia di sé un senso enigmatico,
acuito da una colorazione cupa del corpo, ma dall’evidente linea di contorno
che distacca e solleva dal fondo monocromo il soggetto, in atto di tentare un
incerto (e mal riuscito) nascondimento della propria persona: l’esposizione del
corpo è totale e nonostante la reazione di pudore che trasmette una specie di
vergogna l’uomo è offerto senza paramenti alla vista dello spettatore. In
questo caso, la nudità non è oggetto di desiderio, come è nella classica
visione erotica, ma è l’esteriorizzazione di una condizione materiale ed
esistenziale, da cui volendo ogni soggetto non può sottrarsi: il pudore
accennato non riguarda la vergogna adamitica di ritrovarsi esposto agli sguardi
altrui, ma l’impossibilità di coprire questa nudità senza che questa stessa
azione appaia meno violenta e mendace che il lasciarsi privi di indumenti.
L’immagine schieleiana non intende inscriversi nell’immaginario erotico e darsi
in pasto allo spettatore, eccitandolo o illudendolo su incredibili appagamenti,
ma è il palesamento di una vitalità che mal si acconcia all’ordine culturale: non
un’enfatico ritorno all’ingenua primitività, ma un atto pieno di
consapevolezza, dissacrante non del corpo maschile, quanto dell’intero sistema
culturale che ha codificato alcuni (e solo quelli) paesaggi erotici.
L’accusa di pornografia,
ovviamente mal posta dal pensiero benpensante, è in fondo una conferma del
senso espresso dall’opera di Schiele. Pornografia qui, non consiste
nell’esibizione svergognata degli organi genitali, chiaramente visibili, oppure
in qualche lasciva e sconveniente gestualità dell’uomo, ma nel fatto che la
stessa situazione dell’esistenza umana trovi nel corpo maschile il suo modo con
cui comunicare drammaticità e un certo senso di realismo – evidenziato dalla
peluria delle cosce. In tal senso, l’erotismo di Schiele ricorda il vampirismo
di Edward Munch, vale a dire che non è la dimensione in cui vi si possa trovare
quell’esaltazione sensuale e emancipatrice dell’uomo come in alcuni quadri di
Henri Matisse (Matisse, Joeu de vivre),
che verrà in seguito vampirizzata dalla stessa composizione, ma è il piano di
una nudità che esibisce l’esistenza umana nel suo essere inerme. Una condizione
drammatica che può solo alleviarsi, ma non estinguersi, neanche se si è parti
di una coppia. L’olio su tela di Schiele, dal titolo L’abbraccio (1917), presenta una situazione erotica canonica, la
scena d’amore e di passione di una coppia, uomo e donna, pienamente coinvolti
nel godere l’uno dell’altro e di condividere quella indefinita “verità di
coppia” (cfr. Jean-Luc Nancy) che si rivela solo durante un rapporto sessuale.
Qui, la passione, per quanto intensa, non può negare la condizione
dell’esistenza, anche se la rende meno inquietante e meno cupa: il ricorso al
segno dinamico vangoghiano e alla linea ondulatoria munchiana riversa la
drammaticità insita nella condizione umana in un nuovo dinamismo della forma,
che gli dà movimento, mutevolezza e vitalità.
È difficile dire (diciamo, lo
è per me) quale di questi due erotismi conservi una carica di attualità e forse
non è neanche necessario (e rilevante) stabilirlo, tuttavia quel che conta è il
tema sopra indicato, cioè quale posto è possibile assegnare all’erotismo
nell’immaginario umano, senza che ciò lo svilisca a causa delle strutture
narrative che compongono e definiscono gli spazi semantici con i quali vengono
configurati significati e valori espressi dalla comunicazione ordinaria.
L’opera di Schiele una parziale risposta l’ha data, ma sembra ignorata dal
sistema attuale ordinario e quindi, figurarsi dalla stessa pittura, a meno che
si rinunci al figurativismo, ma questa è una tematica che sconfina i limiti del
registro erotico.
Post Scriptum. La critica di
Friedrich Nietzsche sull’attualità della storia ha avuto ampia diffusione molti
anni fa in Italia, ovviamente a causa della così detta Nietzsche Renaissance, che ha riportato il filosofo tedesco alla
attenzione delle giovani generazioni degli anni Settanta del secolo scorso.
Tuttavia, l’idea nietzscheiana è servita a formulare – non so quanto
consapevolmente – un acritico pregiudizio verso il pensiero sociale e verso i
sistemi ideologici, pregiudizio necessario a quei tempi perché legittimava lo
scontro filosofico tra una irriducibilità della sfera individuale del cittadino
all’astratta volontà dello Stato, che si esprimeva sotto forma di logica di
apparato, burocrazia ed educazione scolastica. Lottare contro questi sistemi e
le loro forme era sì un dovere, in quanto l’Italia degli anni Sessanta non era
stata in grado di consolidare i vantaggi acquisiti dall’inatteso boom economico
di fine anni Cinquanta, ma divenne appunto, anche un diritto, come se si fosse
dinanzi alla scelta di dare esecuzione ad un regicidio: i terroristi dell’epoca
lo avvertirono pienamente questo discrimine e il caos da questi prodotto non è
solo un arbitrio personale o di un gruppo, ma un preciso esito culturale. Ciò
detto, il distacco tra elites di governo nazionali soprattutto e volontà (ma
anche sovranità) popolare pone al centro la questione del valore e della
partecipazione politica, molto prima che il segretario del Partito Comunista
Italiano, Enrico Berlinguer, si inventasse questa idea astratta (e bizzarra) di
“questione morale”, indicando con questa etichetta una categoria concettuale e
linguistica di grande successo che raccoglie tutti i mali possibili (corruzione,
malversazione, indifferenza, …) prodotti dalla classe dei politici italiana e
di governo in particolare, che per molti storici è diventata il preannuncio di
ciò che sarà l’inchiesta milanese contro la corruzione operata dal Partito
Socialista, nota come “Mani Pulite” e la caduta di quella che un tempo si
chiamava “Prima Repubblica”. La fine di un’intera epoca politica, avvenuta
tramite la mannaia giudiziaria e l’orrore di due sconvolgenti stragi mafiose
nell’estate del 1991, hanno de facto
azzerato il corso ordinario della storia della Repubblica Italiana, ma ne hanno
aperto un altro che credo non si sia ancora del tutto concluso. Un nuovo
indirizzo della storia dunque, ma anche una diversa narrazione di fatti e
situazioni che compongono l’attualità di oggi e quella di domani (e chissà per
quanto tempo). Ecco un aspetto perverso nel tema della memoria e che in
Nietzsche si configura come “attualità”, cioè la capacità di poter estendere
ben oltre i limiti temporali di un evento il suo ricordo e di inscriverlo
altresì in una memoria collettiva che finisce per assimilarlo a luogo comune e
a stereotipia. L’esaltazione che Nietzsche fa della “inattualità”, quasi fosse
un titolo di merito indiscutibile e che appartiene alle elitès e non al popolo,
alla massa, tocca proprio questa linea sottile della costruzione ideologica del
ricordo, del pensiero sociale e più in generale degli eventuali programmi
politici di una nazione o di una società: non siamo più all’epoca del poeta
Pindaro dove il ricordo delle Termopili poteva essere manomesso per ricostruire
la dignità nazionale dei Greci, ma ciò non significa che non esistono forme di
costruzione della memoria collettiva o di influenza. Dicevo, il punto è che la
attualità, o ciò che possiamo indicare come tale, non è altro che il sentimento
diffuso e condiviso di una nuova narrazione imperante, come in fondo l’imporsi
di una nuova moda o di un nuovo fenomeno sociale, con la differenza che in
alcuni casi la questione su cui ci si imbatte è più complicata di quella relativa
alla scelta di un taglio di sartoria. In fondo, Benedetto Croce, figura
fondamentale nella cultura italiana del ‘900, non era stato molto chiaro in
cosa consistesse effettivamente la “contemporaneità”, per cui siamo abbastanza
convinti che se “attuale” significa “contemporaneo”, e quindi “attualità” e
sinonimo di “contemporaneità”, allora di certo è possibile affermare che il suo
opposto sia ciò che chiamiamo con il termine “passato”, per poi rimanere basiti
e meravigliati quando scopriamo che mutatis
mutandi qualcuno, magari qualche professore o uomo di cultura, ci fa
credere che esiste per un certo evento un “ricorso” storico, come se l’essere
stati nazisti o fascisti sia una ineluttabilità del futuro che ci toccherà
ripetere. Quanto vario e variabile è l’applicabilità delle strutture narrative
al mondo della cultura, e quanto forte sia il suo potere euristico di
riplasmare forme e contenuti, il che non ci assicura su autenticità di immagini
e sul loro genuino valore non ideologico: forse si ha bisogno di coscienza
critica, o si dovrebbe puntare nuovamente su qualcosa di questo tipo, ma mi
pare che ci fu una svendita alcuni decenni fa di banconote di “coscienza
critica”, che ha portato ad una deflazione da cui non si è ancora usciti, e a
quanto ne so neanche la banca nazionale è più in grado di cambiare i pochissimi
biglietti che sono attualmente in circolazione...