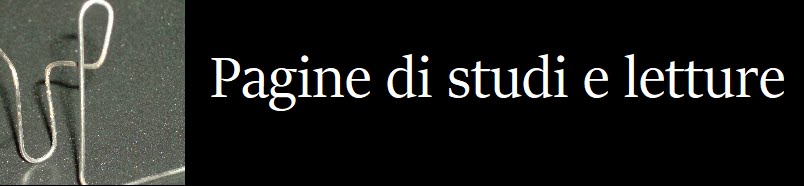La produzione attuale di immagini è
incentrata in buona parte su un complicato intreccio di varie attività, si va
dalla produzione fotografica alla creatività pubblicitaria, fino a giungere
alle scenografie cinematografiche ed ai soggetti delle serie televisive o dei
format televisivi. In ogni caso, un intreccio che trova il suo fulcro nel più
ampio sistema della comunicazione odierna, che non solo richiede sempre più
immagini – spesso ridondanti ed usurate – che descrivano con efficacia e
chiarezza gli eventi che attraversano i meccanismi di tale sistema, ma li
produce anche, nel senso che induce ad un’elaborazione di specifiche immagini
che circuivano adeguatamente per tutta la filiera, direttamente o
indirettamente. Un intreccio inestricabile, disorientante ed auto celebrativo, ma
anche inevitabile e che è strettamente correlato alla funzione delle strutture
narrative (cfr. storytelling),
strutture che sono diventate ormai essenziali in questo vasto mondo della
comunicazione (cfr. Semiologia).
In apparenza è impensabile ammettere che
possa esistere un’attività formale ed estetica odierna che sia in grado di
sottrarsi a questa situazione e non è detto che debba necessariamente
divincolarsi da questo stato. Anzi. La stessa attività fotografica odierna
fatica ad elaborare soggetti che possano codificare messaggi al di fuori dai
diffusi riferimenti categoriale del pensiero sociale attuale; tra questi
riferimenti la stessa realtà o la vita senza filtri sono categorie mediatiche e
non solo condizioni predefinite e preesistenti dell’atto comunicativo. Inoltre,
si è imposta un’idea di fotografia che preferisce evidenziare la sua dipendenza
dal realismo estetico, visto che l’unica forma di fotografia-realtà è quella
dei reporter di guerra, mentre tutte le altre formule ricadano nella fotografia
di costume, pubblicitaria e comunque, non documentaristica. Una concezione che
deriva in parte dalla situazione odierna, in parte da alcune direzioni
dell’arte contemporanea, in parte dall’esigenza di fissare un limite, forse anche
un confine escludente con la realtà virtuale, che proprio tramite il digitale
sembra aver debordato sulla materialità dell’esistenza: vita e virtuale si
sovrappongono e l’immagine non ha più nessun elemento di materialità che ne
possa decretare la sua veridicità realistica o ontologica.
L’evoluzione di una parte della
produzione estetica indotta dalle piattaforme social spinge con forza sulla
stessa irrilevanza materiale delle immagini, per cui le campagne di denuncia o
di progresso sociale, incentrate su una o su un sistema di immagini, debbono
ricorrere a codici di immagini, spesso già presenti nel piano sociale e nel
pensiero sociale. Un esito di per sé non imputabile dai nuovi mezzi di
diffusione virtuale, ma che di certo è ampiamente amplificato e quindi, dietro
una mole immensa di produttività estetica non c’è solo una sfrenata creatività,
ma anche l’esigenza di replicare e riformulare codici di informazioni necessari
per la vita sociale e forse anche per la stessa vita materiale della società e
delle nazioni: un riflesso condizionante e decisivo del simbolismo sulla stessa
configurazione materiale della società, sui consumi, viene raccontata da
Umberto Galimberti (1942) in un suo libro.
Ciò detto, anche l’attività fotografica
non è esclusa da questa situazione, anzi, per le varie attività a cui si è
legata nel tempo ne è diventato lo strumento essenziale, ed in alcuni frangenti
il cardine stesso come è accaduto negli anni Ottanta del secolo scorso. Oggi,
le tecniche fotografiche sono sensibilmente cambiate, in alcuni casi
riformulate nell’ottica delle nuove tecnologie digitali, ma costante è rimasto
il connubio raggiunto tra iconografia e comunicazione, quest’ultima intesa non
solo come campo di diffusione, ma anche come fonte primaria della stessa
immagine fotografica. Ciò rende quasi impercettibile la commistione delle
tecniche fotografiche ed in molti casi la stessa convertibilità di tali
tecniche per ottenere effetti sempre più sorprendenti ed appaganti. Quest’uso
combinato di tecniche è reso possibile da un lato dalla formazione dei
professionisti attuali, dall’altro lato da una serie di dispositivi fotografici
e da esigenze commerciali che chiedono e richiedono questo tipo di soluzioni.
Un esempio è l’estensione della tecnica fotografica dello still life per i ritratti, spesso ritratti di nudo ed in bianco e
nero, anche se la tecnica è stata pensata per la fotografia a colori e per la
produzione pubblicitaria – si basta scorrere i profili social dei fotografi
professionisti per accorgersi di questo tipo di soluzioni.
Nulla di grave ben inteso e spesso i
risultati sono estremamente accattivanti, ma questa direzione della fotografia
non è solo un esito dello sviluppo tecnologico dei dispositivi fotografici, dietro
questo fenomeno interviene anche una evoluzione del discorso delle attività
formali, discorso da cui la fotografia non è estranea e che come detto, ha
contribuito a formulare.
È in questo scenario che si colloca l’opera
fotografica di Missy Suicide, al secolo Selene Mooney Castellanos, che ha dato
inizio ad un fenomeno sociale ed estetico di portata globale. Quello che per
molti – compreso il sottoscritto all’inizio – è solo un fenomeno di costume e
forse anche un fenomeno sociale, è in realtà, uno di quei prodotti della
cultura pop di inizio millennio. L’aspirazione di formulare una nuova e diversa
definizione di bellezza, poi fissata dalla cultura antagonista e dal mainstream mondiale nell’estetica del
tatuaggio o degli inked model, deriva in primis da un’intuizione primigenia di elevare il criterio
soggettivo di bellezza a valore generale, criterio fissato dal principio che la
bellezza risiede negli occhi di colui che guarda e non nel soggetto che si
mostra, che in seguito diventerà il canone fondamentale di un programma
militante antitetico al circuito ed al sistema della moda: un carattere questo
che si è caricato nei forum dedicati a questo modello di bellezza in modo
ideologico e ciò ha fatto eludere che a suo modo il sistema della moda stesso
proprio in quegli anni ha cercato di riformulare in chiave soggettiva i canoni
sociali ed ufficiali; in pratica, tentando di dire quanto verrà affermato dalla
svolta degli inked model. Comunque,
il fenomeno delle Suicidegirls – nome che deriva dal titolo del sito internet
omonimo da cui inizia la diffusione di questo paradigma estetico alternativo –
rappresenta un fatto estetico che sconfina dall’ambito del fenomeno di costume
o della nuova moda giovanile. L’ideale come detto, è più ambizioso, è la
riformulazione del concetto di bellezza – come titola il volume per il quinquennale
della fondazione del sito suicidegirls.com
«beauty redefined» - ed uno stravolgimento dell’iconografia della moda e del
sistema della comunicazione.
Ora, se il successo dell’iniziativa
imprenditoriale nel campo del web ha attribuito significati differenti da
quelli fissati dall’intuizione originaria e spesso, ha trasformato
l’iconografia inked in una forma di
contestazione, in genere di rifiuto dell’ordinario sistema estetico, per
diventare esso stesso paradigma ed iconografia, le idee che hanno animato
l’impegno di Missy Suicide sono poche, semplice ed in buona parte collegate ad
una certa situazione della fotografia mondiale.
Il primo dato rilevante è quello che in
seguito diventerà il tema di arrivo di un percorso evolutivo della stessa
immagine SG, vale a dire quell’idea di definizione di un canone estetico
alternativo, se non in netto rottura con i clichés imposti dal sistema della
moda e dai trend commerciali. Nel suo primo volume, semplicemente intitolato Suicidegirls
(2001), Missy Suicide avverte fin da subito quest’esigenza di definizione di un
nuovo canone estetico, vissuto dalla fotografa anzitutto come uno spazio
sociale, come dimensione di un incontrarsi e solo in seguito come un’esigenza
estetica. Infatti, fin da subito la via intrapresa è quella delle nuove
tecnologie internet, cioè l’utilizzo di spazi virtuali come a.e., la
rudimentale ed originaria bacheca dove gli iscritti del sito venivano in
contatto tra loro, creando una primitiva comunità di persone accomunati da
particolari sensibilità, o semplicemente da gusti estetici diretta espressione
del proprio mainstream di
riferimento. Il tema della libertà di ogni individuo e soprattutto quello della
riconoscibilità delle differenze che caratterizzano tali identità sono le
premesse fondamentali per una riflessione estetica alternativa, più “sentita”
che non teorizzata – quest’ultimo aspetto verrà in seguito. Infatti, è
l’ambiente giovanile della fotografa statunitense a dettare i termini di questa
riflessione, ammesso che all’epoca ci fosse una solida consapevolezza di ciò.
Missy Suicide è stata una fotografa
amatoriale, oggi produttrice ed imprenditrice, che ha vissuto gran parte della
propria giovinezza nello stato dell’Oregon, precisamente nella città di
Portland. La sua formazione fotografica è essenzialmente autodidattica,
composta durante gli anni del college, e spesso associata ai modelli della
fotografia delle riviste patinate che colleziona e dei molti magazine per
adulti come Playboy e Penthouse, da cui trae il suo ideale iconografico di
riferimento, la Pin-Up (Betty Page). L’ambiente sociale (giovanile), culturale
e la situazione economica della città di Portland tra gli anni Novanta ed i
primi anni Duemila descrive l’attecchire di una cultura pop orientata
chiaramente al multiculturalismo. Una vitalità ampiamente avvertita dai giovani
e che lascia traccia di sé nelle opinioni della fotografa, nelle scelte
anticonvenzionali e non stereotipate che iniziano a realizzare fin dalla
giovinezza e soprattutto per quel gusto sulle formule inconsuete e bizzarre che
la orientano verso la cultura post-punk e all’internazionalismo etnico della neocultura
hippy.
Questi scorci biografici, accennati
nell’introduzione del volume fotografico menzionato, indicano con una certa
evidenza un’attitudine amatoriale che ricorda certe idee di un’altra fotografa
statunitense Diane Arbus (1923-1971), con la quale condivide l’assenza di
alcuna pregiudizialità estetica verso i soggetti e di una sorta di anarchia di
metodo degli strumenti usati per realizzare le proprie fotografie, ma anche
delle scelte su ambientazioni e su situazioni. Dal punto di vista estetico
l’attività amatoriale o il non professionismo è l’eredità più evidente della
svolta documentaristica che proprio la fotografia degli anni Sessanta, ed in
particolare proprio l’opera fotografica della Arbus e di altri, ha impresso nel
discorso delle attività estetiche, nell’arte contemporanea di fine Novecento e
in specifico nell’attività fotografica. In una certa misura, l’approccio alla
fotografia e la stessa idea di fotografia espressa da Missy Suicide non sono
molto lontani da questa forma di attività amatoriale che contraddistingue la
fotografia a partire dalla seconda metà del secolo scorso: il professionismo
della fotografia si confina infatti, nello spazio delle immagini glamour e dei
messaggi commerciali, mentre ai fotografi amatoriali compete, per così dire, la
ricerca estetica tout-court, l’innovazione,
l’inusuale.
È in questi termini che Missy Suicide si
approccia all’attività fotografica, evitando cioè di seguire modelli
prestabiliti o preconfezionati, ma così facendo orienta il suo apprendistato
fotografico verso il libero sfogo della propria curiosità e considera
l’attività fotografica più che una ricerca estetica come il “documento” di ciò
che in qualche modo si mostra come una stravaganza interessante, meritevole di
attenzione. Siamo lontani dall’idea oggi molto in voga di una fotografia dettata
da ragioni di composizione estetica, incentrata su una progettualità in cui
ogni componente della fotografia è strutturato in un equilibrio formale appagante;
qui, ciò che guida la fotografia sono solo le sensazioni, disordinate forse ed
indeterminate che coinvolgono la fotografa durante i set fotografici. Non c’è
progettazione, non c’è composizione formale, non c’è alcuna preventiva
valutazione di come potrebbe apparire la stessa fotografia. Tutto è lasciato
alla casualità dell’impressione o della impressionabilità. Ecco allora,
delinearsi un’altra caratteristica della fotografia di Missy Suicide.
Il multiforme interesse della fotografa
verso tutte quelle forme bizzarre o comunque, verso quelle forme inconsuete,
trasgressive e rigettate dall’iconografia ufficiale è motivato non solo da un
istinto proprio, ma anche da una precisa scelta iconografica compiuta sulle
illustrazioni di Alberto Vargas (1896-1982) – tra l’altro citato dalla stessa
fotografa. La fotografia non può essere il mezzo di una codificazione
prestabilita, che si limita alla sua diffusione, ma diventa l’atto con cui dare
espressioni a combinazioni imprevedibili, almeno nelle intenzioni della
fotografa: la fotografia come “improvvisazione”, ma non nell’uso della tecnica.
Se l’arte di metà Novecento si è interrogata sulle varie contaminazioni tra le
forme, contaminazione necessaria visto che la crisi della figurazione
tradizionale, in quanto l’accostamento bizzarro, spesso scandaloso – come ha
mostrato il movimento Dada – ha in sé la condizione per il superamento delle
aporie estetiche, la fotografia, pur seguendo un percorso affine, ma in fondo,
autonomo rispetto all’evoluzione dei temi dell’arte, si è concentrata
unicamente nella definizione di alcuni pochi modelli di riferimento ed al
perfezionamento di quelle tecniche fotografiche che permettessero la loro
realizzazione al meglio. L’incontro tra arte tradizionale e fotografia è vissuto
da entrambe le attività come fortuito ed occasionale, anche se la direzione
semiologica della pittura europea e mondiale fornirà ad entrambe uno spazio
comune di intervento, cioè le figure di un immaginario diffuso e condiviso
plasticamente rappresentato da pubblicità e comunicazione. Questa dimensione
virtuale tiene insieme sia l’iconografia erotica di Vargas, sia il piano
astratto dell’immaginario tout-court,
abolendo in fondo, le distinzioni categoriali e costruendo le nuove forme
nell’ottica di una continuità formale, quella stessa che ha portato la Pop Art
al tema del recupero e del riciclo di materiali inconsueti o addirittura
scartati dal mercato dei consumi. È in questa particolare situazione dell’arte
novecentesca che si colloca l’idea di fotografia che nel tempo la fotografa di
Portland preciserà.
La libertà e soprattutto la convinzione
della fotografa di Portland che la bellezza sia una qualità che non riguardi le
categorie estetiche codificate dalla società e tuttavia, il gusto che sottende a
tale giudizio è in buona parte influenzato dalle convinzioni morali sulla
bellezza e sulle opportunità stabilite dal sistema sociale. In tal senso,
l’attività fotografica può limitarsi a descrivere questa situazione, ma entro
certi limiti anche ad intervenire. L’intuizione fondamentale è quella di
sottrarre allo sguardo del fotografo il monopolio del giudizio estetico e ciò
viene realizzato tramite gli scatti personali realizzate dalle stesse modelle
riportati a corredo del primo volume – siamo ancora in epoca pre-selfies!
Ovviamente, è una scelta che segue ancora l’idea di fotografia amatoriale che
caratterizza il libro menzionato della fotografa, ma introduce un concetto
nuovo di voyeurismo creando una possibilità espressiva che solo nell’epoca
attuale dei selfies si può intendere. Anche se sul piano espressivo non si può
evitare che una logica di consumo possa influire nella stessa rappresentazione
fotografica, il fatto che ora la macchina fotografica passi di mano dal
fotografo al modello o al soggetto fotografato crea una situazione di
“intimità” inedita, ma anche un edonismo che non cerca la trasgressione ad ogni
costo, ma eleva a trasgressione la natura stessa del corpo esibito, della
nudità offerta senza altri costrutti e orpelli. La bellezza naturale, seppur
alterata dalla presenza delle forme tatuate, impone un clichés che costringe
l’osservatore a soffermarsi oltre la immagine stessa, che è in fondo, lo scopo
ricercato dalla fotografa. In ogni caso, la nuova direzione offre una immagine
che non corrisponde perfettamente alle esigenze dei vari processi della
comunicazione, vale a dire all’esigenza di codificare categorie già note e
diffuse; non ha l’esigenza di rendersi appetibile ad ogni costo e quindi, non
asseconda scopi commerciali; non ha l’esigenza di imporre modelli di
riferimento.
Assecondare questa direzione significa dunque,
eliminare la presenza del fotografo dal campo della immagine. In tal senso, si
ritrova la lezione del fotografo francese Jeanloup Sieff (1933-2000) e precisamente
nell’idea di una fotografia che cerca di non violare l’intimità della nudità
femminile, tanto che le fotografie sono realizzate in ambienti casalinghi, per
lo più salottieri, e con pose in cui la modella è ritratta per lo più di spalle
o senza indugiare troppo sulla fisionomia del volto: corpi anonimi certo, ma
corpi in libertà, corpi che esprimono sensazioni e sentimenti comuni ad ogni
donna o essere femminile. Nell’intuizione di libertà assoluta di Missy Suicide
si può ritrovare, facendo le debite differenze, questa lezione, soprattutto
nella definizione di uno sguardo voyeur non più di matrice maschile, ritenuto
invadente e stereotipato. Il voyeurismo erotico che Missy Suicide viene a
codificare non deve intendersi solo nei termini di «soft porn» come ha
dichiarato la pornostar americana Angela White (1985), ma come una necessaria
«offerta visiva», che non sia solo un simbolo o una superfetazione, semmai deve
intendersi una dichiarazione pubblica di un genuino atteggiamento naturale del
nudo. Una nudità libera e non sovraccaricata dal peso della composizione
formale o dalle esigenze di perfezione dei canoni imposti e proposti dai
messaggi pubblicitari: il corpo così come si trova, con le sue imperfezioni. Il
nudo in Missy Suicide è anzitutto libertà, ma soprattutto è accettazione di sé.
Questi concetti hanno bisogno di un
linguaggio fotografico che riesca a rappresentarli e tale linguaggio è fatto
di:
-
Una
ritrattistica che riprende l’impostazione della fotografia di posa, sia
nell’ambientazione minimale sia nell’uso dei fondali monocromatici. Ciò
conferisce alla fotografia un carattere amatoriale e l’idea di un apprendistato
non ancora pienamente compiuto. Tuttavia, è una caratteristica non voluta –
tanto che verrà a perdersi nei lavori successivi della fotografa - che però, concettualmente segna un discrimine
forte con la fotografia patinata del sistema della moda a cui in parte
s’ispira: sembra quasi incompatibile la polemica verso i canoni ufficiali di
bellezza proposti dalla moda e mirare poi a Betty Page come icona erotica che
in qualche modo ne è feticcio. Quello che in fondo, appare una sorta di
contraddizione indica l’aspirazione di elevare a paradigma estetico ciò che non
viene riconosciuto come tale; è, in fondo, la riformulazione di una bellezza
soggettiva che è percepita sotto forma di gusto estetico e che non può
rientrare tra i canoni di giudizio sociali. La moda e la stessa società aspira
a riferirsi a modelli estetici assoluti, anche se poi la storicizzazione di
questi modelli rivela il loro relativismo storico e generazionale. Nella
fotografia di Missy Suicide prevale l’esigenza inversa di quella espressa a.e.,
dalla fotografia di un Jeff Dunas (1954) e cioè elevare ad immagine pubblica
quella bellezza che non è intesa, né percepita come tale: le grandi top model
degli anni Ottanta sono il modello di un paradigma di bellezza assoluto ed in
quanto tale sono un fatto pubblico, le modelle di Missy Suicide, soprattutto se
sono inked model, non descrivono
questo paradigma ed in quanto tale non sono riconosciute come un fatto sociale.
Almeno fino al clamoroso (e crescente) successo del sito web Suicidegirls.
-
La
composizione non è la priorità espressiva delle fotografie di Missy Suicide,
anzi il senso di amatoriale che caratterizza il suo primo lavoro rivela un
netto rifiuto a questo criterio e la stessa idea espressa dalla fotografia
sembra essere il risultato di un’improvvisazione, di quelle intuizioni che
conferiscono al costrutto fotografico un mood non replicabile.
-
In
tal senso, la fotografia diventa un sistema che trae il proprio codice di
lettura interpretativa e di giudizio non più da canoni esterni all’immagine
stessa. E quindi, il racconto di sé delle modelle, il loro umore e le loro
aspirazioni, che come detto corredano ed accompagnano la fotografia di
informazioni di altra natura rispetto all’immagine, intervengono sul giudizio della
stessa fotografia da parte dell’osservatore. A tal riguardo, la presenza del
tatuaggio non è un fatto estraneo o secondario, ma la fotografa statunitense ha
agito come se il tatuaggio non esistesse, come se la fotografia fosse il
prodotto di un’attività convenzionale. Ancora adesso non ho ben compreso se ciò
sia segno di una “visione naturale” dei corpi tatuati, vale a dire che per il
senso comune attuale è indifferente se un corpo sia o non sia tatuato, oppure
se ciò sia solo di un’indifferenza non adeguatamente valutata dalla stessa
fotografa. Il tatuaggio non è una forma “esclusa” dal sistema della
comunicazione, è un oggetto ed una forma che porta con sé regole e significati
che deriva dai sistemi culturali che lo hanno elaborato, per cui trovarlo sulla
pelle di un modello non è un fatto così ovvio. Il tatuaggio, in base alla forma
ed all’estensione, chiede di essere trattato dalla fotografia con una certa
accortezza, in quanto può influire negativamente sull’equilibrio complessivo
dell’immagine. Nel caso il tatuaggio incide sulla relazione erotica che l’immagine
intrattiene con l’osservatore: tale rapporto non è più quello tradizionale
della fotografia erotica, la sensualità della nudità maschile o femminile viene
quasi soffocata dalla preponderanza feticistica innescata proprio dalla
presenza del tatuaggio: in un certo senso, i tatuaggi, soprattutto su alcune
zone erogene del corpo umano, possono avere l’effetto di amplificare il
carattere feticistico, carattere che appartiene strutturalmente alla dimensione
erotica, ma che in questo caso straborda a tal punto da opprimere un eventuale
insorgenza di desiderio. Non so se questi effetti siano valutati dalla fotografa
statunitense di certo, un osservatore per nulla abituato all’invadenza visiva
del tatuaggio potrebbe rimanere sconvolto ed infastidito: certo, tra gli scopi
dell’iniziativa di Missy Suicide vi è quello di costringere lo spettatore a
superare il mero dato biologico e scrutare, diciamo così, nell’«anima» della
modella, ma è indubbio che la fotografia di un corpo tatuato non è un’attività
neutra e deve fare i conti con i problemi di composizione estetica e con i
codici cromatici alternativi richiamati dal tatuaggio.
In conclusione, se il fenomeno delle SG
è correlato in qualche modo con le dinamiche dell’arte del ‘900 tale fenomeno
ha una sua primordiale origine su un’idea di fotografia di per sé non innovativa,
in quanto recupera un modo di fare fotografia che le stesse riviste della moda
degli anni Ottanta avevano abbandonato, con l’adozione negli anni Novanta di altri
criteri di valutazione estetica e di composizione. Tuttavia, su una forma di
linguaggio fondamentalmente obsoleta trova collocazione una precisa esigenza
estetica che proprio all’inizio degli anni Duemila trova modo di imporsi,
quella di diffondere stili e moduli espressivi provenienti dal mainstream e dalla cultura
urbano-metropolitana. Per una qualche ragione non perfettamente storicizzata
questo fenomeno che si afferma come fatto sociale nasce in realtà, come un
fatto estetico e precisamente, come una diversa idea di fotografia. L’intuizione
e forse anche la sensibilità della fotografa di Portland coglie effettivamente
una lacuna estetica, a cui tenta di rimediare, ricorrendo in ogni caso a
formulazioni già ampiamente utilizzate, ad un codice estetico riadattato alla
nuova idea e ad un gusto per il bizzarro. Se per Missy Suicide la sigla SG è e
rimane l’espressione di un’attitudine, di una consapevolezza più o meno
determinata di sé, per il resto del mondo è un fatto sociale che conferma una
direzione già presente nella creatività della moda, cioè l’idea che ogni
individuo è un essere unico e per certi aspetti irripetibile e l’abbigliamento
e tutto ciò che è correlato alla moda sono forme espressive di questa unicità. La
moda infatti, proprio negli anni Duemila, comprende che non è più lei a dettare
le norme del bel vestire o del buon gusto, ma è la personalità dell’uomo o
della donna alla moda, è il loro grado di eccentricità, la loro passione e la
loro voglia di dare un’immagine pubblica di sé, la loro personalità. In ciò le
SG non sono un fenomeno alternativo, contrariamente a quel che pensano i
cultori dell’inked, semmai è una diversa formulazione dello stesso concetto
estetico già formulato dal sistema della moda, magari forse con una maggiore
consapevolezza ideologica e con un’attitudine maggiore verso le contaminazioni
e la non convenzionalità.
Porto Empedocle, 25/09/2021 (modifiche
del 26/09/2021)